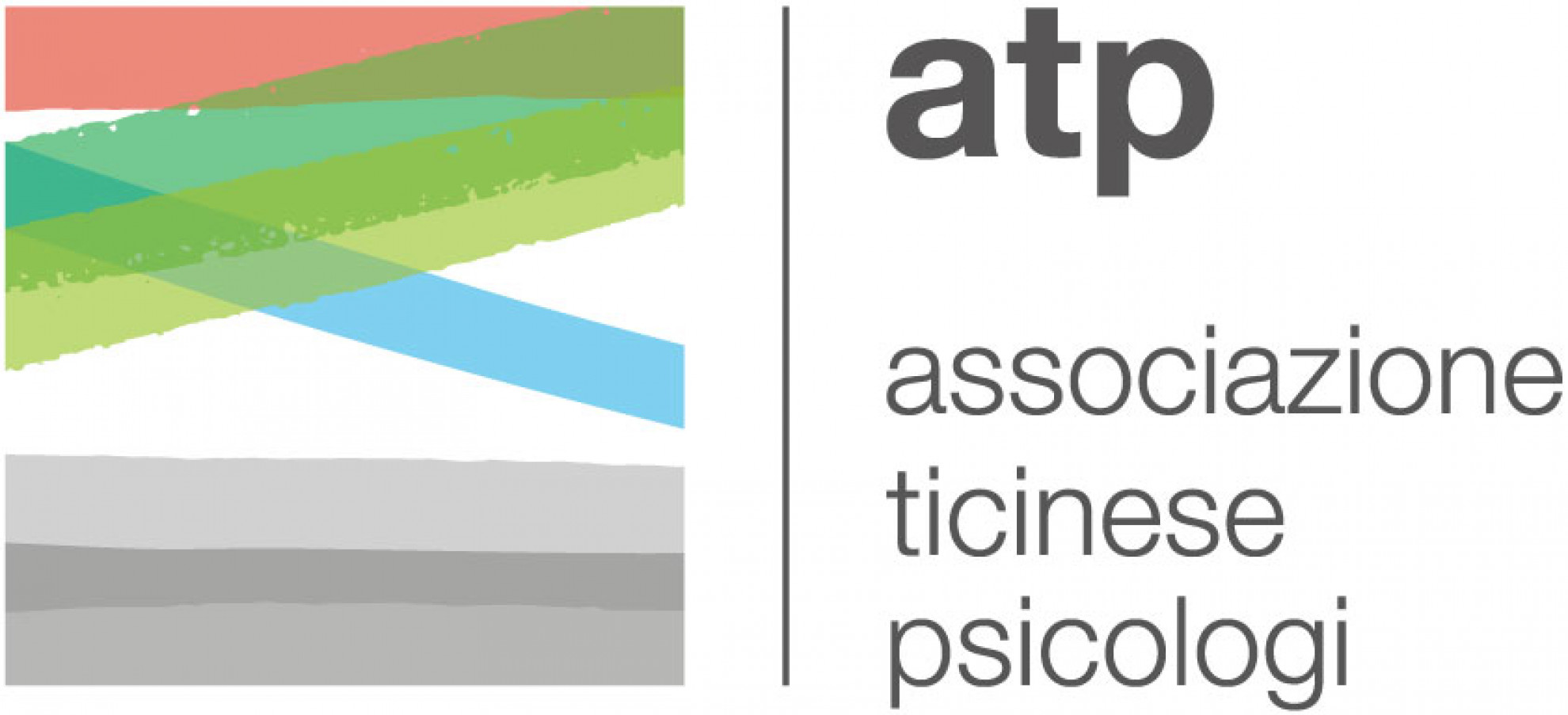Imparare a morire per imparare a vivere
Nel tempo abbiamo disimparato a conoscere la signora con la falce. Eppure non è nostra nemica, ma un tassello del nostro vivere

L’uomo è l’unico essere vivente per cui la morte non è solo un evento, ma anche un problema, poiché sa di dover morire, e questo sapere suscita angoscia. Il problema non è tanto la morte in sé, quanto la coscienza della stessa; coscienza che muta con il mutare della società, della cultura, della religione e, in generale, della concezione della vita. Essa viene studiata da più punti di vista – psicologico, biologico, filosofico, antropologico –, ognuno dei quali considera il trapasso secondo la sua visione particolare, rispondendo in modo diverso alla domanda cos’è la morte? La visione della morte cambia, quindi, non solo in base all’evoluzione dell’uomo e della sua storia, ma anche in base all’angolazione da cui si sceglie di guardarla.
Tutta la vita che ci gira intorno
Nonostante sia stata oggettivizzata come un’entità esterna al vivente, qualcosa che arriva, essa non è solo un fatto che si può oggettivare, bensì anche un vissuto in quanto costituisce un aspetto del vivere, dal quale è indissociabile: il senso del morire, infatti, appartiene al senso del vivere. Vivere significa assumere la certezza di morire: da quando l’essere umano è diventato consapevole della sua finitezza ha contemporaneamente iniziato un infinito dialogo con, e su, questo evento. Tutto ciò è importante poiché è proprio in base alla risposta che l’uomo dà alla domanda cos’è la morte che esso desidererà morire in un certo modo e organizzerà l’aiuto ai morenti, affinché muoiano bene, e alle famiglie, affinché elaborino nel miglior modo possibile il lutto e riescano a tornare alla vita. L’evento della morte è, dunque, integrato in un contesto sociale e culturale che è soggetto a trasformazione continua. Ora, non è questa la sede per una digressione sugli sviluppi storici, filosofici, religiosi e sociali del concetto del fine vita, è importante però non dimenticare che il nostro modo di rapportarci ad esso è fortemente e indissolubilmente legato all’epoca e al contesto in cui viviamo, nonché al punto di vista privilegiato che scegliamo di abbracciare.
L’oblio del Novecento
Il secolo appena trascorso ha prodotto una situazione inedita nella civiltà occidentale, dando luogo per la prima volta nella storia a un’illusoria pretesa di immortalità: si è passati da quella che Ariès ha chiamato morte addomesticata (un contatto diretto e casalingo con la mortalità, durato fino al tardo Medioevo) alla morte proibita.
Da un lato, il ’900, soprattutto dopo la Seconda guerra mondiale, è stato il secolo della rimozione della morte dalla vita quotidiana: la messa in discussione di valori e tradizioni, il terrore provocato dai conflitti e dai totalitarismi, il progresso tecnico e scientifico in ambito medico e il boom economico degli anni 60, hanno relegato il morire dietro le quinte dell’accadere quotidiano, lontano dal palcoscenico della vita. Essa è stata esiliata all’interno degli ospedali, gestita nel modo più asettico possibile dalle équipe mediche, cercando di tenerla lontana dai riflettori della quotidianità, rendendola una questione privata, da vivere quasi con imbarazzo e da superare il prima possibile: come se, allontanandone da noi il pensiero e l’immagine, se ne potesse allontanare la realtà. Dopo il Novecento, la morte non è più rappresentata come esito naturale e parte inscindibile della vita, essa è diventata un’entità esterna a noi, cattiva, legata al male e al sovrannaturale. Oggi la sua rappresentazione è diventata una specie di tabù moderno, guai a parlarne (prendendo il posto del sesso e della sessualità). D’altro canto, il secolo scorso si è impegnato nella spettacolarizzazione dell’accadere della morte: nell’ambito dell’informazione e del giornalismo i termini usati sono sensazionalistici e scandalistici, termini che la raccontano come un evento eccezionale e singolare, un evento spaventoso che riguarda gli altri e mai l’Io in prima persona, da temere ed evitare. Lo scorso secolo ha quindi nascosto la naturalità del morire, celando la morte negli ospedali e narrandola come una sconfitta e un fallimento, qualcosa da combattere e vincere. Ciò ha reso possibile, in Occidente, la diffusione di una percezione di immortalità e inattaccabilità che ha portato alla quasi scomparsa dell’accettazione della propria e dell’altrui fine; come se la morte fosse una punizione per qualche colpa commessa o il compimento di un disumano raggiro cosmico.
Un’arte da coltivare con attenzione
Ma non è sempre stato così: la morte, avvenimento comunque triste e doloroso, era approcciata con molta più dimestichezza e normalità. I funerali fermavano la vita di un intero paese e il rapporto con l’ambiente e i suoi cicli facilitava un approccio diverso nei confronti della fine: la natura parlava quotidianamente di morte e rinascita, con la notte che segue sempre il giorno, la decomposizione di un frutto che genera nuova terra pronta per la vita. Il morire era, in passato, un’arte da coltivare con attenzione e, sin dai tempi antichi, si credeva che il modo migliore per prepararsi alla morte fosse allenarsi a morire: i Greci, ad esempio, usavano la meditazione e la riflessione come esercizio spirituale attraverso il quale superare il timore della fine e vivere liberi. Forse, oggi, riportare la morte e il morire all’interno della riflessione e del quotidiano è quello che potrebbe servire per dare un senso all’angoscia e un significato alla vita, per uscire dall’individualismo eccessivo in cui siamo intrappolati e riconsegnare un valore al futuro, proprio e altrui. Tornare ad insegnare il morire, la caducità, il limite, è di vitale importanza per affrontare l’angoscia dell’ignoto, così come per donare nuovamente senso e valore alla vita e al futuro. Un tempo finito, limitato, è un tempo che va apprezzato e utilizzato al meglio; fingersi o pretendersi immortali e inattaccabili produce l’esatto contrario. Al giorno d’oggi si insegna di tutto, ci sono corsi e seminari per qualsiasi cosa: quello che ancora sembra mancare quasi totalmente è un’educazione al morire. Come se imparare ad affrontare questa inevitabile fase della vita non fosse importante e pertinente; come se fingendo che essa non esista si potesse veramente riuscire a schivarla. Dopo un secolo passato a tentare di nascondere la morte dalla quotidianità e dall’orizzonte di significato dell’essere umano, gli adulti di oggi sono i primi che andrebbero di nuovo educati al morire, in modo da poter trasmettere tale sapere ai figli per detabuizzare la fine della vita.
Le domande sono fondamentali per continuare a ricercare
Educare alla morte non significa spiegare cosa sia e cancellare il mistero che l’accompagna; significa piuttosto portare in superficie le domande per renderci conto che, anche se non sapremo mai cosa essa sia davvero, è lecito chiederselo e desiderare di saperlo; al di là dell’adesione o meno a un singolo punto di vista. È la capacità di imparare a porsi le domande, senza eluderle o ignorarle, cercando di svelarle nonostante l’impossibilità di riuscirci: un pensiero sempre in movimento, sempre alla ricerca di maggiore profondità. Insegnare agli adulti e ai loro figli quanto sia significativo porsi le domande, senza crescere e vivere all’ombra di un unico punto di vista: imparare a desiderare l’ignoto come possibilità di svelamento. Tutti i tentativi di spiegazione prodotti fin qui dall’uomo assumono, quindi, pari valore e dignità (siano essi religiosi, scientifici o filosofici) e ciò che più conta è muoversi all’interno di essi, ponendosi sempre nuove domande e sollecitando nuovo desiderio di sapere: allenarsi quotidianamente a esplorare nuovi universi e a compiere viaggi negli ignoti mondi della nostra interiorità, per desiderare la morte come dissoluzione della coltre di angoscia e mistero che la circonda. È inutile voltarsi indietro e scappare dal presente per cercare di eliminare la paura dell’ignoto che ci aspetta dopo la morte. L’io e la morte sono inscindibilmente legati, sia da un punto di vista biologico (l’evoluzione della specie prevede che la materia organica si trasformi e venga continuamente “riciclata” nel ciclo della vita), che da un punto di vista esperienziale: in assenza di io non si ha la morte e il morire in quanto oggetto esperienziale è costitutivo dell’io. Lo sforzo del secolo scorso di celare questo evento è quindi stato vano, e il nuovo millennio si è aperto con una significativa rinascita dei temi relativi al morire: quella che un tempo era la meditazione dei filosofi, oggi sta cercando di tornare ad essere riflessione comune e quotidiana, per rendere di nuovo l’uomo capace di morire e, quindi, di vivere. Uno dei principali obiettivi dell’educazione al morire è quello di rendere le persone in grado di riappropriarsi di un’idea realistica della morte: essa non va negata, è propria di ognuno e ci accomuna tutti; è un fatto inevitabile della vita, che fa parte del nostro essere umani fin da quando veniamo al mondo.
Fragili e di passaggio bisogna pensare al futuro
Il percorso di questo tipo di educazione assume un valore importante anche rispetto alla rappresentazione della fragilità della vita e, quindi, della necessità di rispettarla. L’incapacità di pensare la morte è, infatti, un rischio per il futuro dell’umanità: non avere consapevolezza della propria fragilità e di quanto delicato sia il vivere riduce, a tratti, l’intera umanità alla stregua di un adolescente che sfida i limiti e la fine, quasi si trattasse di un gioco. Eludere il tema del morire ha, inoltre, tra le varie conseguenze, eliminato il concetto di progresso e ricchezza da tramandare alle prossime generazioni, derivando da ciò la negazione della responsabilità rispetto al futuro. Eliminare la consapevolezza della finitezza della nostra vita ha provocato un senso di indifferenza nei confronti delle condizioni in cui si troveranno i nostri figli, il nostro futuro, negando ogni nostra responsabilità. Ecco perché imparare a morire (attraverso la riflessione, la meditazione, il pensiero critico e la spiritualità) vuol dire anche, e soprattutto, imparare a vivere: essere consapevoli di quanto sia delicata l’esistenza terrena permette di rispettarla in tutte le sue forme e durante tutto il suo tempo. Per affrontare il senso della morte è dunque necessario e fondamentale restituire al linguaggio contemporaneo il senso del morire e guarire dall’afasia culturale novecentesca che circonda la fine della vita. La parola defunto non ha nessuna accezione negativa, essa deriva dal verbo latino defungor – che ha compiuto la missione –: la morte può quindi essere considerata un dono, il premio per chi ha portato a termine la sua strada, il coronamento della propria esistenza e della propria ricerca dell’ignoto. La morte non nega la vita, anzi è ciò che la rende possibile, al parti della nascita. Vivere educati al morire significa vivere consapevoli di avere a disposizione solo una certa quantità di tempo, che va amato e valorizzato, usandolo anche per fermarsi a riflettere e meditare sul suo significato e sulla sua fine, per arrivare a costruire il desiderio di poter conoscere finalmente cosa c’è dietro di essa.
Una rubrica a cura di