Studenti a distanza, toccati nella mente e nel cuore
Le riflessioni sul periodo pandemico nella didattica dello storico Marco Meschini fra ‘maturati d‘ufficio’ e valutazioni ‘gonfiate’
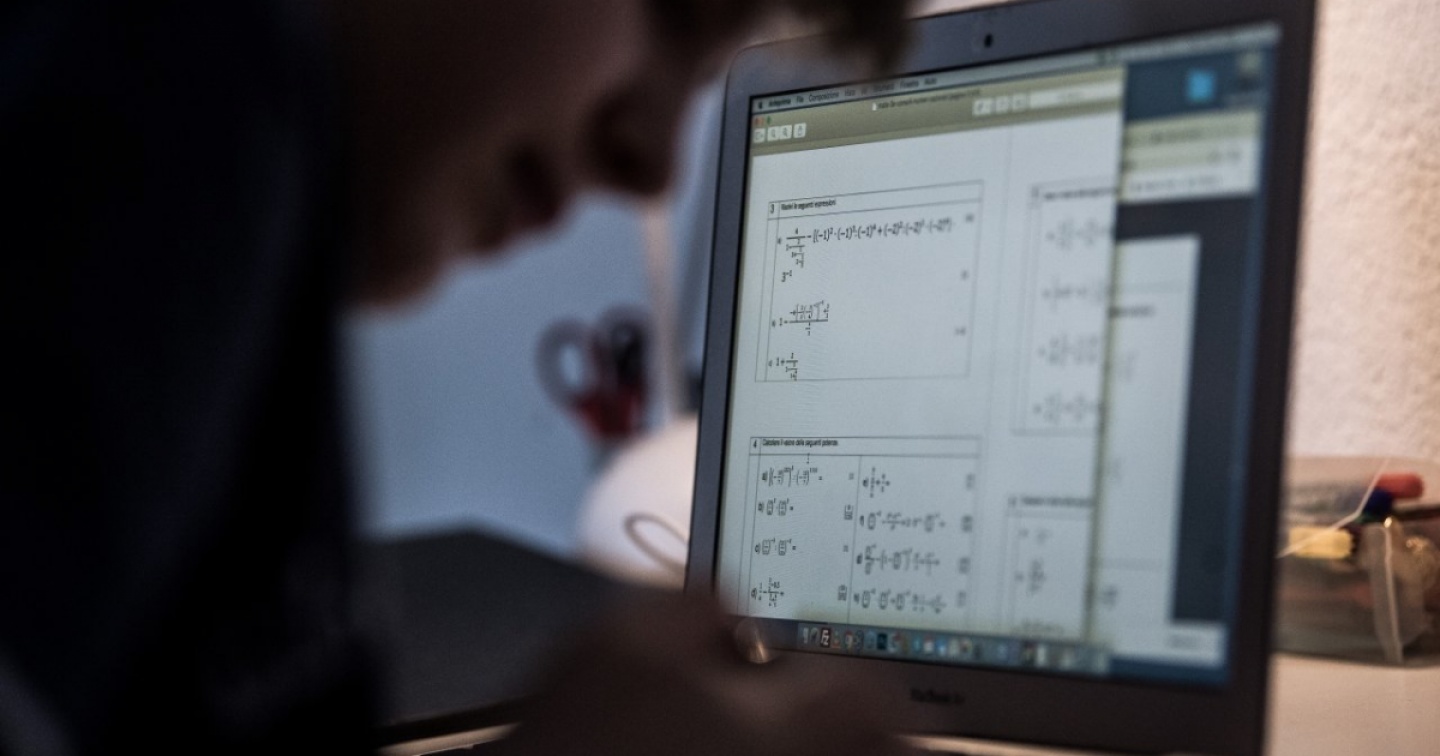
Ha sempre osservato il mondo della scuola molto da vicino, non solo per formazione ma anche per interesse (numerose le sue collaborazioni con istituti di ricerca internazionali) Marco Meschini, storico ed esperto di comunicazione, nonché formatore di public speaking per il Cantone Ticino e direttore del liceo Everest Academy di Lugano. Sotto i suoi occhi e nei suoi studi anche la pandemia che, chiudendo in casa tutto un mondo, ha costretto i più giovani alla didattica a distanza.
Il nuovo coronavirus ha letteralmente «sconvolto le nostre vite», oltre che imporre – come ha fatto notare in sue recenti riflessioni – «una sfida radicale a chi si occupa di formazione ed educazione». Cominciamo dalle criticità: quali sono stati i maggiori cambiamenti che il Covid ha portato nel mondo della scuola?
Direi soprattutto una distanza straniante. Di colpo, il mondo della scuola ha dovuto fare a meno della presenza, che è la pre-condizione normale ed essenziale del suo “essere” e del suo “fare”. Il lockdown ha colto gli attori sostanzialmente impreparati, perché la “presenza distante” (diciamo la didattica a distanza, che è una forma di comunicazione intermedia fra presenza e assenza) non era affatto prevista, a parte alcuni rari casi. Di qui, un affanno globale e anche decisioni sorprendenti, come per esempio – per il nostro Cantone – quella di non svolgere gli esami di maturità… Nelle difficoltà si resiste.
La didattica a distanza ha mutato il rapporto maestro-allievo? Come? Con quali effetti negativi? E positivi, se ve ne sono…?
Assolutamente sì. La “lezione” è un atto comunicativo performativo, che necessita della presenza dei suoi “attori”. Verbale, paraverbale e non-verbale, contesto, emissione e ascolto…: tutto è stato sconvolto e lo si è dovuto ridefinire di corsa e in corsa. Pensiamo alle lezioni a distanza: docenti e studenti si sono ritrovati in uno spazio “altro”, ovvero lo spazio digitale, senza reali mezzi di comprensione e interpretazione, a parte come fruitori di siti internet e social media. Di qui, l’esplodere delle inadeguatezze, dei ritardi, delle ritrosie… Non dimentichiamo che, per natura, la scuola è un’entità conservatrice, sottoposta in questo caso a una drammatica accelerazione di aggiornamento-innovazione-ripensamento. Questi ultimi mi sembrano gli unici – per quanto parziali – elementi positivi.
Quanto alle sfide post-pandemia?
La pandemia ha svelato che il mondo “reale” è intriso di digitale, nel triplice senso di strumenti, media e cultura. Ora, la scuola può ripiegarsi nel suo universo “a parte”, tornando a elementi puramente tradizionali, oppure integrare il meglio della tradizione con quanto il mondo di oggi può offrire, e che appunto nella pandemia è stato vitale per non perdere del tutto il rapporto con il suo pubblico, vale a dire gli studenti e le famiglie.
Crede che l’assenza di ‘presenza’ abbia portato nei giovani effetti quali frustrazione e senso di disagio? Il non essere più, cioè, parte di una comunità?
Siamo nell’aprile del 2020, è passato un mese di didattica a distanza e sono le 10.30 del mattino: dal mio studio sento un urlo al limite dell’umano: è mia figlia di 10 anni che piange e urla disperata, «voglio tornare a scuola!». Certo, esistono anche profili meno “sociali” di mia figlia, ma mi pare sia un esempio molto chiaro: non siamo monadi, abbiamo radicalmente bisogno degli altri.
La tecnica, considerata spesso, anche in modo ingiustificato, “social”, pare non abbia invece aiutato a mantenere quelli che lei ha definito come «cervelli accesi». Perché? Dove si è sbagliato?
Non è mai la tecnica in sé a determinare il grado di attivazione di un cervello. Posso usare uno schermo per scorrere a polliciate un flusso infinito e indistinto di immagini, video, audio… – attivazione 0,1% – oppure usare lo stesso schermo per stimolare il ragionamento e la discussione. Tutto dipende dagli obiettivi formativi e dal grado di competenza didattico-educativa degli attori coinvolti, a partire dai docenti. Per questo la formazione ad hoc degli adulti responsabili è fondamentale, anzi basilare.
Lockdown e relazioni a distanza influiranno sulle nuove generazioni? In quali forme?
Temo proprio di sì, tra qualche anno parleremo di “generazione Covid” per riferirci ai nostri figli che sono stati toccati nella mente e nel cuore dalla pandemia e dai suoi effetti scolastici. Ho già ricordato i “maturati d’ufficio”, ma so anche che troppe scuole hanno alzato le note di 1-1,5 punti… Mi pare francamente troppo, e comunque sbagliato.
Anche gli insegnanti hanno dovuto rivedere la loro didattica. Crede che ne siano usciti vincitori solo quelli che lei definisce «maestri vivi»?
Anzitutto bisogna dire che, nel complesso e dopo il primo momento di smarrimento, il “corpo” docente ha reagito, si è messo in discussione, ha tentato di rispondere e corrispondere. Penso che la società debba riconoscere che non c’è stato un fuggi-fuggi generale, ma un rimboccarsi le maniche e provarci: in diversi casi inadeguato, ma reale. Come accennavo prima, inoltre, serve un nuovo concetto di formazione rivolto ai docenti per affrontare con metodo questi nuovi linguaggi: il digitale è molto di più di un semplice set di strumenti, non si può affrontarlo a penne nude. Detto questo, di veri “maestri vivi” abbiamo sempre bisogno, e forse tanti hanno sentito con più acutezza l’urgenza di questa stessa “vivezza”.
Da quale elemento la scuola sarà chiamata a portare una “nuova” normalità?
La pandemia ha mostrato che la viva relazione interpersonale è la pre-condizione essenziale per “essere” e “fare” scuola, a qualunque livello. Da qui, da un riaccogliere la presenza dell’altro – che non è sempre un genio, un volenteroso, uno che ce la farebbe in qualunque contesto… – si deve ripartire. Perché la scuola ha senso se esistono gli studenti, altrimenti diviene passato senza futuro.







