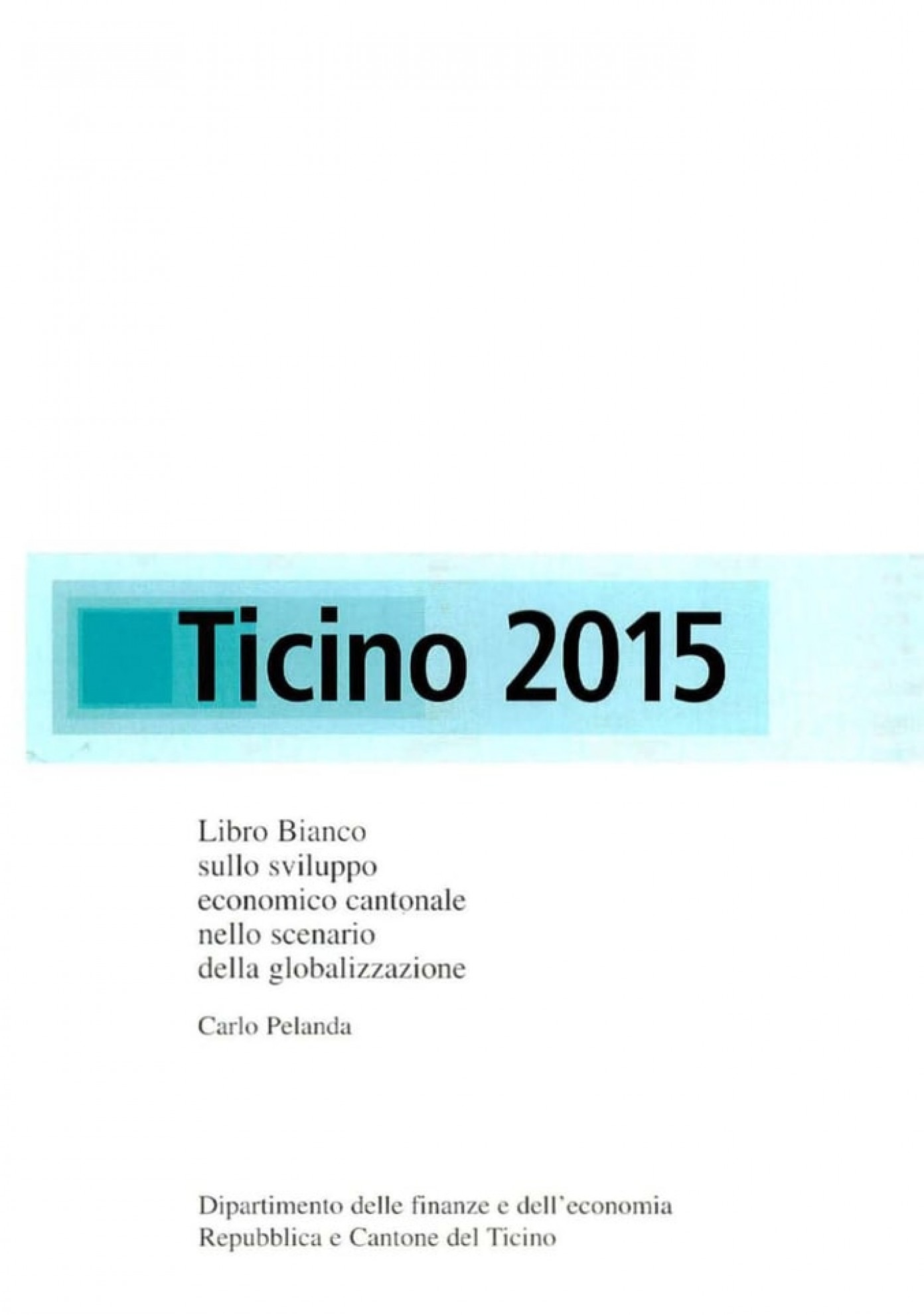Il Libro Bianco, 25 anni dopo
Il 23 marzo del 1998 usciva quello che fu poi considerato il manifesto del liberismo ticinese di Marina Masoni. Ne parliamo con l’economista che lo curò
- ‘Cantone campus’, innovazione, laissez-faire tra le ricette previste
- Liberismo galoppante o ‘liberalismo pragmatico’?
- Cosa ne resta, col senno di poi

Nel 1998, a riempire i cinema sono l’apocalisse di ‘Armageddon’ e i flirt ridanciani di ‘Tutti pazzi per Mary’. Vasco Rossi rimugina cupo su "come alla fine mi hai ridotto tu…", ma Alex Britti gongola poppeggiando che "finalmente faremo l’amore". Negli Stati Uniti Bill Clinton si becca l’impeachment per una fellatio mentre Apple lancia il colorato iMac nella bolla dotcom. Anche il Ticino è un pendolo che oscilla tra malumore e speranza: si è al settimo anno consecutivo di recessione economica, ma il peggio pare passato e imperversano le prospettive di ‘rilancio’. Non ultime quelle provenienti dal Dipartimento delle finanze e dell’economia guidato dalla liberale Marina Masoni, portabandiera – insieme al segretario generale Sergio Morisoli, oggi capogruppo Udc in Gran Consiglio – del liberismo glocal.
Proprio tra crisi presente e ottimismo per il futuro si colloca il loro manifesto intitolato ‘Ticino 2015. Libro bianco sullo sviluppo economico cantonale nello scenario della globalizzazione’, "finito di stampare presso la tipografia Rezzonico, Locarno, il 23 marzo 1998, giorno di S. Vittoriano". Sviluppato da un gruppo di lavoro che include anche i rappresentanti dell’impresa e delle banche, il libro bianco è sì permeato dal principio del laissez-faire, ma anche dalla convinzione che lo Stato possa governare le direttrici dell’innovazione economica e agevolare un nuovo patto di Paese. 272 pagine che all’epoca molti commentarono, ma forse pochi lessero, e che oggi – insieme alle ‘101’ misure’ di due anni prima – sono ancora sinonimo di ‘masonismo’. Le abbiamo spulciate prima d’intervistare Carlo Pelanda, l’economista che curò la relazione. Classe 1951, all’epoca professore presso la University of Georgia, Pelanda è stato consulente scientifico di svariate istituzioni internazionali e commentatore del ‘Giornale’ e del ‘Foglio’. Oggi è presidente di un grande fondo d’investimento, Quadrivio Group, ed editorialista su ‘La Verità’ e ‘Milano Finanza’. Il suo ultimo saggio è ‘La riparazione del capitalismo democratico’, Rubbettino 2021.
Professor Pelanda, come mai fu chiamato ad analizzare il contesto ticinese? Conosceva già questa realtà?
Il mio profilo era abbastanza noto a livello mondiale per aver partecipato a una serie di think tank e progetti sia accademici che operativi, occupandomi tra l’altro del rilancio competitivo dell’Italia e di altre realtà territoriali. Un giorno mi arrivò l’invito della signora Masoni, che aveva sentito parlare del mio metodo improntato al liberalismo pragmatico, disposto a confrontare con la realtà tutte le teorie – sia liberiste che socialiste –, per poi sviluppare un approccio basato sui fatti, invece che sulle ideologie. Proprio quello che cercava Masoni, persona entusiasmante che voleva risvegliare un Ticino ricco, ma stagnante: mi disse che voleva generare un piccolo terremoto per smuovere un po’ le acque del dibattito locale, naturalmente però in modo riflessivo e costruttivo. A titolo di curiosità, aggiungo che la mia famiglia migrò un paio di secoli fa dal Ticino verso il Lago di Como. Ma con la realtà ticinese non ho mai avuto commistioni, anzi proprio per questo credo di essere stato chiamato: per ‘rompere le palle’ scrivendo esattamente quello che pensavo, come l’avevo scritto a Washington, a New York, a Roma e così via.
Le indicazioni del libro bianco miravano a proiettare il Ticino in un mondo globalizzato, scegliendo il "rilancio competitivo" invece della "decadenza controllata". Tra le ricette: sviluppo di un ‘cantone campus’, diversificazione dei servizi dentro e fuori la piazza finanziaria, condizioni attrattive per le imprese innovative. Il tutto in nome di "un modello liberista socialmente efficace", perché "nell’età del turbocapitalismo solo il modello di ‘capitalismo liberista’ appare sostenibile": dunque anche meno tasse, welfare ridimensionato e affidato, come altri servizi fondamentali, a fondazioni e no profit private. Col senno di poi, è ancora convinto di quella ricetta?
Certo. La ricetta giusta è quella di lasciare più libero il mercato, consapevoli che il modello politico deve cercare la configurazione del capitalismo di massa, nelle grandi nazioni come nei piccoli territori. È anche una questione di equilibrio della democrazia, messa in crisi quando il sistema, inceppandosi, genera non solo perdita di ricchezza, ma anche della speranza di poterla acquisire; e ciò per una crisi del modello socialista, ma anche di quello liberista. Lo avevo già scritto insieme a Giulio Tremonti (ministro delle Finanze dei governi Berlusconi, ndr) ed Edward Luttwak (economista e politologo statunitense, ndr) nel libro ‘Il fantasma della povertà’ del 1995, in cui si auspicava un riequilibrio delle garanzie: meno garanzie redistributive, che bloccano il mercato, e maggiori garanzie per acquisire le competenze adeguate a un’economia competitiva in un mondo globalizzato, il quale, piaccia o no, non è un mondo gentile. Credo che anche Masoni lo avesse letto e ne fosse impressionata.
Insieme al gruppo di lavoro chiedevate un welfare "di aiuto e non di ostacolo al mercato come, invece, è ora". La mancanza di una bibliografia rende tuttavia difficile ritrovare dati a supporto di questa e altre tesi. Non avete temuto di ‘moralizzare’ questioni più tecniche?
Ma no, anzi. Il concetto da me ideato è quello di "welfare d’investimento", alternativo a quello redistributivo come pure alla mancanza di welfare, ma anche alla terza via che pretende di accostare elementi inconciliabili del socialismo e del liberismo. Propongo dunque uno Stato sociale che investa sugli individui per rafforzarli, invece di spendere per mantenerli deboli. Un’evidenza formidabile, ma molto contrastata politicamente, perché richiede di mutare schemi incancreniti da decenni, da quando è finita l’illusione dell’accesso alla ricchezza per diritto. Nella mia visione lo Stato deve dare garanzie e il mercato ricchezza, mentre spesso si pretende che accada il contrario.
Il libro bianco oppone dunque allo Stato "estensivo" quello "intensivo", perché "la nuova missione della politica nell’economia globale è – e sarà oggettivamente sempre di più – quella di attrarre capitali sul proprio territorio". Non è una visione riduttiva, di pura governance, peraltro superata dalla crisi della globalizzazione?
Se partiamo da una visione pessimista, di ‘homo homini lupus’, che secondo me è anche la più prudente, imporsi nella competizione significa attrarre capitali liberi di spostarsi e non più controllati dagli Stati. Questo vale anche oggi, col ritorno del bipolarismo tra blocco sinorusso e blocco democratico, al cui interno la concorrenza resterà comunque spietata. La Svizzera può in parte giocare sulla sua eccezione neutrale proponendosi come cassaforte di tutti, ma sente anch’essa tali pressioni competitive.
Con la fine del segreto bancario questo vantaggio ha lasciato orfana una piazza ticinese piuttosto raffazzonata, dipendente com’era dai ‘soldi facili’ degli evasori fiscali italiani. Si è invece rafforzato un altro vantaggio di confine: la disponibilità di frontalieri a buon mercato che permettono di competere sul prezzo, rimandando l’innovazione. Che fare?
Ancora una volta, occorre tornare all’idea di incentivare industrie tecnologiche, servizi di primo livello sul piano globale e nuove forme di inventiva, sfruttando anche la vicinanza con l’Italia, ma per attrarre profili qualificati. All’epoca proponemmo, oltre al ‘cantone campus’, il ‘cantone giardino’: l’offerta di una sorta di ecologia semiartificiale che creasse un Eden certamente agevolato dalla situazione climatica ticinese, progetto utile a maggior ragione di fronte al cambiamento climatico. Ma molte delle idee che abbiamo proposto non sono state capite.
Lei parla di giardini, ma da allora la politica di sviluppo economico ticinese ha attirato parecchio cemento e capannoni vuoti, imprese attratte solo da prospettive di ‘ottimizzazione’ fiscale. Non si tratta del risultato del vostro approccio liberista?
È una critica ingiusta. Le riflessioni proposte dal gruppo di lavoro nel libro bianco sono state fraintese. È chiaro che se attraggo i capannoni devo metterci dentro qualcosa, ma non è questione di liberismo: l’attrattività fiscale non era pensata per tirare a bordo capitale passivo. Si intendeva uscire da un’economia che viveva di rendita, anche in previsione della fine del segreto bancario che pure ho sempre difeso – per la Svizzera e l’Austria come per San Marino – a titolo di compensazione per i loro svantaggi orografici. Se non si è riusciti a combinare la competitività fiscale con l’innovazione delle produzioni – secondo l’idea ben chiara di Masoni – quello purtroppo è un problema dei ticinesi.
Nel libro si insiste molto su un "patto di competitività" tra politica e impresa, da sottoscrivere a priori per diminuire "il ricorso successivo a negoziazioni dettagliate e conflittuali sui singoli punti". Un’intesa in cui "deve essere chiaro il confine" tra Stato e attori privati. Era davvero una prospettiva realistica, specie nel cantone dei clientelismi, delle famiglie feudali e degli accordi al "tavolo di sasso"?
Io arrivavo dall’esterno – come curatore teoretico, non come protagonista – per applicare un modello d’innovazione. E il modello è quello giusto. D’altronde anche Masoni aveva colto la necessità di modificare un certo assetto ‘feudale’, rimettendo in discussione le rendite correnti in cambio di un maggiore benessere futuro. Se fossi nuovamente chiamato in Ticino ripeterei lo stesso: se volete innovare applicate queste raccomandazioni, altrimenti resterete prigionieri di un declino controllato in un mondo spietato, in cui Stato e mercato devono essere complementari, non conflittuali.
Ma non è proprio quel modello, che rinuncia a un ruolo redistributivo, ad agevolare la crescita delle disuguaglianze?
Ma no, questo non c’entra nulla. Restiamo ai fatti. È molto chiaro quello che un governo, sia nazionale che locale, deve fare in base ai suoi poteri: attrarre il più possibile il capitale, non solo finanziario ma anche umano, tecnologico, sociale, e dentro una griglia di prestazioni lasciare più libero possibile il mercato in chiave competitiva. Questo senza sacrificare l’assistenza, laddove necessaria: in una democrazia non ci si può permettere il lusso di avere troppa povertà, perché il povero vota, e non avendo soldi vota chi glieli dà, facendo degenerare la democrazia. Competere per attirare più capitali, in modo da rendere meno necessario il ricorso all’assistenzialismo, è dunque un requisito di stabilità per il sistema democratico.
Come ha vissuto le critiche ricevute in Ticino?
Mi hanno fatto un po’ ridere, perché provenivano da un mondo antico. È un po’ il problema della Svizzera: ha molti punti di forza – ordine, civiltà, eccetera –, ma c’è una tendenza alla conservazione e all’inerzia che penalizza il sistema, alle cui buone condizioni d’investimento manca qualcosa per essere davvero innovativo e dinamico.
Quel ‘qualcosa’ che trasformerebbe la Svizzera negli Stati Uniti…
Ma io glielo auguro! È l’unico Paese europeo che può aspirarvi: il welfare confederale limita un po’ l’autonomia dei cantoni, ma il suo meraviglioso modello democratico potrebbe consentirlo. Diventerebbe un Paese più caotico, ma capace di reagire continuamente alle difficoltà costruendo nuovi mondi.
CONTROCANTO
Marazzi: ‘Tra Pulp Fiction e il Far West’
«Ha presente quella scena di Pulp Fiction in cui Harvey Keitel si presenta alla porta di Quentin Tarantino, che deve disfarsi di un cadavere senza testa? "Sono il signor Wolf, risolvo problemi". Ecco, mi pare che Carlo Pelanda si sia proposto un po’ così qui in Ticino, rispondendo a Marina Masoni quando cercava qualcuno per mettere ‘ordine’ in un’economia ritenuta inadeguata alle sfide globali». È con asciutta ironia che l’economista Christian Marazzi – professore emerito Supsi e storico osservatore della società e del lavoro ticinesi – rievoca la controversa genesi del Libro bianco, «un documento la cui gestazione fu interna al Dfe, con un gruppo di sostegno che rappresentava i grandi interessi bancari e industriali internazionali, senza coinvolgere realtà locali quali i sindacati e altri corpi intermedi. Una bella differenza rispetto al rapporto Kneschaurek del 1964», in cui le previsioni a trent’anni dell’economista ticinese docente a San Gallo «furono commissionate e condivise dall’intero Consiglio di Stato e videro coinvolti molteplici interlocutori».
Il libro bianco, insomma, fu semmai «un’operazione univoca, improntata fin dall’inizio a un marcato liberismo e mirata a legittimare il passaggio dal vecchio sistema di rendite bancarie – sempre più minacciate dalla prevedibile fine del relativo segreto e da altri stravolgimenti internazionali – a uno di rendite fiscali, basate sulla competizione per attrarre i capitali tramite sgravi e agevolazioni. Dinamiche in ogni caso già in atto e attivamente perseguite, dunque non certo avviate, ma piuttosto giustificate dagli estensori del rapporto». Quando poi incontrò Pelanda, Marazzi ricorda che «parlammo di tutto, fuorché del Ticino. Non so quanto conoscesse e si interessasse davvero alla nostra dimensione specifica. Temo che alla fine il Libro bianco sia stato utile, più che sul piano analitico e teorico, su quello ideologico, per legittimare un paradossale tentativo di ‘rivoluzione dall’alto’».
‘Limitare i danni’
Sergio Morisoli ritiene che le riforme strutturali auspicate in quelle pagine siano rimaste in realtà lettera morta, vittime del fuoco – tutt’altro che amico – di "una processione ventennale e chilometrica di cecchini statalisti". E ribadisce (su ‘laRegione’ del 3 marzo scorso): "Le misure proposte per il Ticino e mai attuate, salvo quelle sul cantone della conoscenza (Usi, Supsi, e laboratori, campus), sono invece state la chiave di successo e sviluppo per quei Paesi e per quelle regioni (anche svizzere) che chiamandole in altro modo (in inglese) le hanno adottate".
Marazzi la pensa diversamente: «Si trattava di una visione estrema della società, ed era normale e anche auspicabile che la dialettica politica si attivasse per limitarne i danni. Non mi pare però che quella ‘filosofia’ sia poi rimasta chiusa nei cassetti, se è vero che da trent’anni assistiamo a una politica di tagli fiscali e sociali, accompagnata dalla costante ossessione per il pareggio di bilancio. Come culmine di questo percorso si può indicare proprio il decreto Morisoli», che impone il pareggio di conto economico entro il 2025 agendo prioritariamente sulle spese. Una traiettoria che «a livello locale e globale ha fatto danni incommensurabili, dall’arrivo di ‘capannoni’ vuoti e insostenibili alla crisi finanziaria internazionale del 2008-2009. Ecco, proprio in quel momento ci si sarebbe dovuti accorgere di cosa sia davvero l’idea di un mercato che più è libero e meglio funziona e si autoregola, nel quale la competizione per i capitali, anche territoriale, genererebbe magicamente ricchezza e benessere: una perfetta finzione teorica. Se non fosse bastata quella lezione, basti ricordare che pochi giorni fa, con il fallimento di Silicon Valley Bank, ci siamo ritrovati nuovamente alle prese col rischio sistemico generato dal mito della deregulation. Nel Libro bianco si trova appunto quell’illusione, la rappresentazione d’una sorta di società del Far West come ideale, che a questo punto risulta smentita dai fatti, eppure si continua a più riprese a vagheggiare».
Nuove prospettive
Ma allora, chiediamo infine a Marazzi, quali potrebbero essere oggi le intuizioni di partenza per avviare il cantiere di un nuovo Libro bianco (o di "quel Libro rosso – come lo chiama Morisoli – che ci fu promesso da parte dei nostri avversari che furono, che sono e che saranno", i quali "ci hanno già fatto perdere quasi un quarto di secolo, speriamo non ce ne rubino un altro")? «Oggi viviamo in società di flusso – premette Marazzi – caratterizzate da massicci e spesso repentini spostamenti di persone, merci e capitali. Ma con il concomitante riflusso della globalizzazione – la cosiddetta de-globalizzazione – e le urgenze che si presentano sui fronti interconnessi dell’energia e dell’ambiente, è necessario individuare nuovi modelli socioeconomici. Modelli capaci di investire sulla formazione per creare, al netto appunto della comunità di flusso, anche e soprattutto una comunità della cura, in cui si preservano e si promuovono il lavoro dell’uomo per l’uomo, i diritti e la dignità delle persone. Credo siano questi alcuni spunti che potrebbero tornare utili oggi». Il tutto, naturalmente, per superare «quella competizione forsennata e sregolata con la quale la visione liberista ha plasmato gli ultimi decenni, coi risultati che sono sotto gli occhi di tutti».