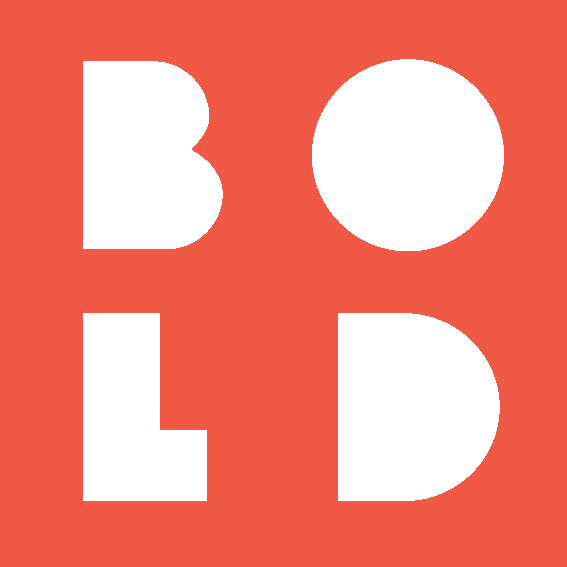
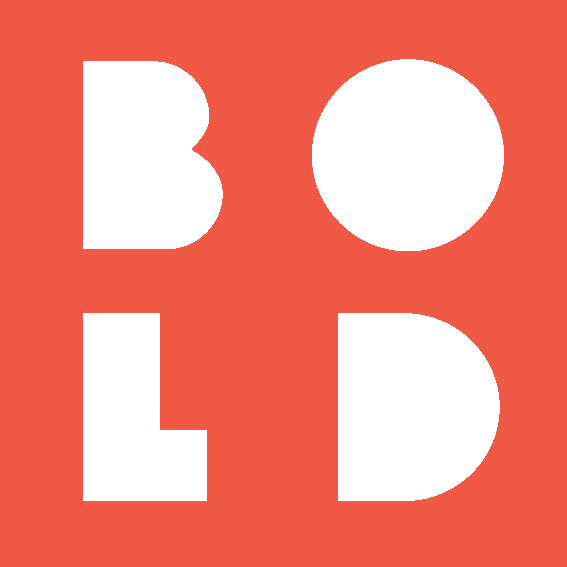
Compie il secolo di vita il Davos, club che con trentun trionfi è il più titolato in Svizzera
A Davos l’hockey è di casa. Vuoi perché vi si disputa il torneo per club internazionale più prestigioso e longevo al mondo (la Coppa Spengler), vuoi per la particolarità di uno stadio che spesso (e a giusta ragione) viene definito la ‘cattedrale dell’hockey’. Oppure ancora perché con i suoi trentuno titoli vinti, la squadra gialloblù è quella che ne ha vinti il maggior numero in Svizzera. Raccolti in cento anni di vita, tanti quanti ne festeggia quest’anno il club. Fondato nel 1918 (su iniziativa del dottor Kurt Wüst) ma che vide effettivamente la luce nel 1921. Cento anni di storia in cui alti (parecchi, con la squadra capace appunto a trentuno riprese di toccare anche l’apice), e bassi non sono mancati. Su tutti la ripartenza dalla Prima Lega nel 1990.
Ma anche dal capitolo forse più delicato della sua storia, il Davos ha saputo ritornare grande, meritandosi in pianta stabile un posto nell’élite nazionale. Non senza togliersi altre importanti soddisfazioni: dal loro ritorno in Lega nazionale A, i gialloblù hanno infatti aggiunto altri sei titoli al loro palmarès.

Tra i protagonisti di quel ritorno nel massimo campionato c’è anche Gian-Marco Crameri, che i colori del Davos li ha portati per sei stagioni. Di cui una, la prima, quando i gialloblù ancora rincorrevano il posto nell’élite nazionale lasciata nel 1989. È infatti nella stagione 1992/93 che Crameri sbarca per la prima volta in quello che ancora si chiamava Eisstadion, con il Davos che allora milita in Lega nazionale B (ritrovata dopo un solo anno di purgatorio in Prima Lega). Alla transenna c’è Mats Waltin. «Ricordo quegli anni con particolare emozione – racconta l’oggi 48enne –. Davos in fondo è stata la mia prima squadra ‘vera’ dopo aver fatto quello che un tempo si chiamava l’apprendistato col St. Moritz. È con i gialloblù che ho fatto il mio esordio sulla scena dei ‘grandi’ scalando gli ultimi due gradini dei valori nazionali: dapprima, quella stagione, nel campionato cadetto, e poi, l’anno seguente, in Lega nazionale A». Già, perché al termine di quell’annata, Crameri e compagni conquistano l’agognata promozione, battendo i ‘cugini’ del Coira in tre partite nello spareggio promozione/relegazione (best of 5). «Anni prima, con il St. Moritz, mi era capitato di affrontare il Davos nel campionato di Prima Lega, ed era stata una cosa quasi surreale, pensando al palmarès che i gialloblù si portavano appresso. Perciò il giorno del nostro ritorno in Lega nazionale A fu memorabile, e non solo per noi giocatori: aver ritrovato un posto tra le grandi dell’hockey nazionale è stato un sollievo per tutti, entourage compreso, ma anche il pretesto per una grande festa collettiva. La fine di un incubo iniziato nel 1989. Io ero ancora giovane, ma tutto sommato lo era anche gran parte del gruppo che si ritrovava per le mani Waltin. Questo ci ha permesso di crescere e migliorare ancora».
Si sentiva il peso di rappresentare il club più titolato della Svizzera? «Bene o male ogni squadra ha il suo motivo d’orgoglio. A Davos sono i titoli, a Lugano la qualità che i tifosi si aspettano che i giocatori portino in pista ogni partita, altrove altro ancora… Quando sei alle tue prime esperienze da giocatore è possibile che ti faccia un po’ influenzare da queste cose, ma col passare degli anni, non ci badi più: sono più i tifosi a prestarci attenzione». E quello di giocare nella ‘cattedrale’ dell’hockey? «Per uno come me, che prima di lì giocava in una pista a cielo aperto, la prima volta è stata una grande emozione. Anche dopo, quando ci avevo un po’ fatto l’abitudine, era sempre comunque qualcosa di speciale. Del resto speciale lo è stato anche giocare a Lugano, dove il calore e la vicinanza dei tifosi suscitava altrettante emozioni uniche».

Cosa rappresenta per te il Davos? «Beh, essendo nato in Engadina, dove vivo tutt’ora, il Davos è ovviamente il club di riferimento per quel che concerne l’hockey. Quando giocavo ancora a St. Moritz, tifavo già per il Davos dei vari Ron Wilson, Lance Nethery ed Enrico Triulzi. Erano un po’ i miei idoli. Poter vestire la maglia di quella squadra di lì a qualche anno per me è stato come un sogno che si avverava. È stato lì che la mia carriera è iniziata per davvero, e per questo Davos avrà sempre un posto speciale nel mio cuore, ancora oggi che l’hockey non è più la mia priorità. Ci gioco ancora, con mio figlio, a St. Moritz, in Seconda Lega, ma allo stadio ci vado poche volte: una o due all’anno a Davos, e qualcun’altra a Lugano. Non sempre però ne ho la possibilità, visto che a St. Moritz guido lo spazzaneve, attività che spesso mi impegna anche la sera».
Dopo quattro anni con i grigionesi Gian-Marco Crameri, come detto, è sbarcato in riva al Ceresio (restandoci per quattro stagioni), festeggiando nel campionato 1998/99 il primo titolo della sua carriera. Dopo quello conquistato con i bianconeri, nel 2000/01 arrivò quello vinto con lo Zurigo, e da ultimo quello con la maglia del Davos, storia del 2006/07. «A Davos ci sono tornato per le mie ultime due stagioni ai massimi livelli: l’anno del mio terzo titolo e quello successivo. Fin dall’inizio sognavo di chiudere la carriera lì dove l’avevo cominciata, e l’ho appunto fatto. Il terzo titolo è stato un po’ come la ciliegina sulla torta della mia carriera, una sorta di regalo anticipato prima dell’ultimo giro di pista, l’anno seguente. Se non ricordo male, la sfida decisiva (gara 7) l’avevamo vinta 1-0 contro il Berna, con rete di Leblanc… Ricordo però benissimo che quelle due ultime stagioni le giocai da difensore, dopo essere stato impiegato praticamente sempre davanti: è stato qualcosa di strano. Quella, a ogni buon conto, era davvero una squadra speciale, forte, anche grazie al fatto che molti di loro erano parecchi anni che giocavano assieme. In più alla transenna c’era un allenatore altrettanto speciale: Arno Del Curto». E che tipo di persona era Arno? «Non era tanto la tattica a caratterizzarlo come allenatore, ma i modi che aveva. Arno era uno che si sforzava di provare sempre cose nuove in allenamento, spronandoti a fare ogni volta un passo in più. Per rendere l’idea dei suoi sistemi di lavoro, la preparazione estiva si articolava su quattro sedute giornaliere: tutto un altro mondo rispetto alle altre realtà che ho conosciuto nell’arco della mia carriera. Logicamente a settembre eri forse più affaticato, ma questo modo di lavorare ti permetteva di arrivare a fine stagione più in forma delle altre squadre. Arno, a ogni buon conto, era anche un allenatore dal grande lato umano: non esitava a concederti una giornata di libero in caso di bisogno, a patto però che l’indomani ti ripresentavi motivato e pronto a dare il massimo».

Detto di Del Curto, quali sono gli altri nomi che secondo te hanno fatto la storia, passata e recente del Davos? «In un secolo di storia, di persone rappresentative per la società ce ne sono davvero parecchie. Ma a mio modo di vedere quelle più importanti di tutte sono quelle che hanno fondato la società: senza la loro dedizione, difficilmente staremmo qui oggi a parlare dei cento anni del club. Allo stesso modo, importanti lo sono state le persone che hanno riportato il club nell’élite nazionale a inizio anni Novanta, facendo sì che ci rimanesse in pianta stabile. Dalla prima all’ultima persona, dal presidente all’addetto alla biglietteria. Ognuno è una tessera di questo grande mosaico che si chiama Davos».