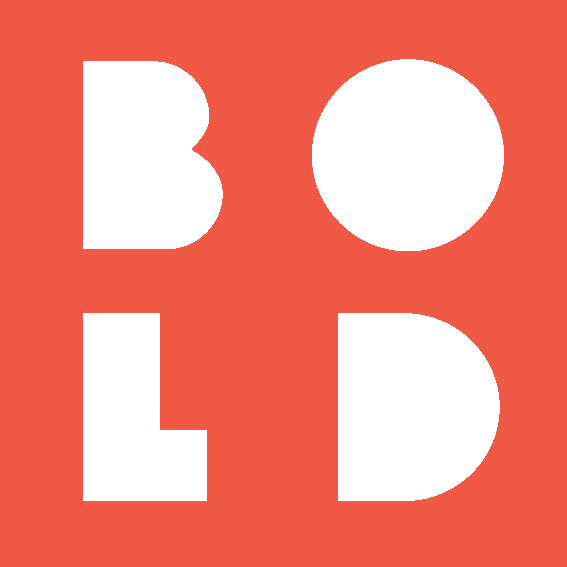
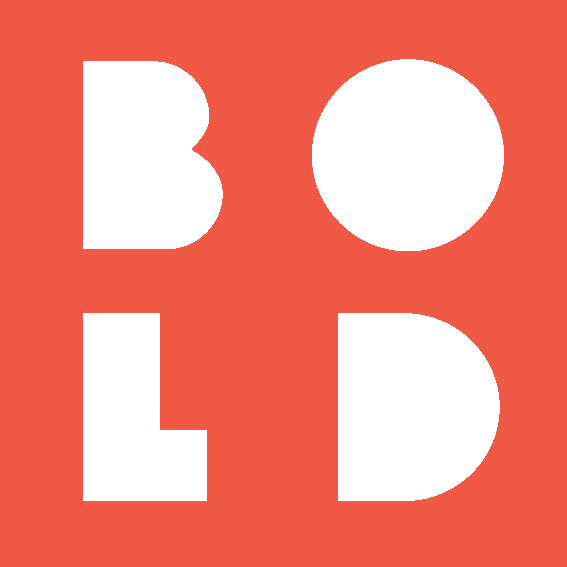
Vent’anni da quel summit organizzato male e finito peggio, che portò morte e violenza. E dove la polizia si macchiò di crimini indegni per un Paese civile
Vent’anni dopo: potrebbe essere passato un secolo o un solo giorno. Il G8 di Genova, lo scempio del luglio 2001, è ancora una ferita aperta e al tempo stesso una lezione da imparare. È un fallimento pubblico che racconta soprattutto d’irresponsabilità. Un’irresponsabilità politica (italianissima, ma non solo) che colpì con un timbro drammaticamente duro: sospendendo senza alcun mandato lo Stato di diritto e precipitando nell’abisso la forza pubblica. In quel clima, travolto dai manganelli e dalla violenza gratuita degli squatter, finì stritolato un movimento civile che era riuscito a indicare una piattaforma di valori e azioni, che, in realtà, è ancor oggi non solo possibile ma necessaria.
La scintilla era stata la clamorosa mobilitazione di una galassia trasversale, multiculturale e policentrica di 1’184 sigle da tutto il mondo. L’etichetta noglobal è ingiusta e superficiale, ma descrive l’innegabile amalgama di queste anime, così differenti eppure compatte nell’additare le grandi potenze mondiali e il loro apparato di potere economico come responsabili dell’ingiustizia, della divaricazione sociale, economica e umanitaria che al tempo (e oggi) divideva il mondo. Una rivolta pienamente politica, che univa suore e preti, sindacalisti e ambientalisti, femministe e contadini, centri sociali e pacifisti, insegnanti e studenti, operai e disoccupati, post comunisti e libertari, credenti e agnostici: un ceto sociale e di base che chiedeva pari opportunità, per tutti. Che non aveva trovato né sponda né risposte nella politica istituzionale e per questo si era via via ingrossato.

La politica italiana, infatti, non fu sfiorata né dal dibattito programmatico né dall’escalation del confronto pubblico che quella piattaforma aveva innescato. I ministri e i leader di partito del tempo, impantanati in un’anestetizzata concezione della contesa sociale, prima determinarono un diabolico vuoto di potere (con i governi di centrosinistra), poi lo riempirono con l’ingombrante peso della cieca repressione (con il governo di centrodestra). È una catena di errori che nutrì l’incubo che pervase la polizia e i carabinieri, abbandonati alla piazza dai rispettivi capi, più intenti a puntellare le loro carriere che a garantire la (vera) sicurezza.
Il precipizio ha passaggi precisi. Il primo fu la scelta stessa di Genova come sede del summit. Il premier italiano Massimo D’Alema, quando la prese, non poteva non sapere che quella era diventata una scelta disgraziata: ormai ogni vertice internazionale era bersagliato da contestazioni, l’onda cresceva inesorabilmente e Genova era la peggior città possibile per difendere un evento di quella portata mediatica. Ancora avrebbe potuto farlo il potente successore, Silvio Berlusconi, che invece preferì mostrarsi sicuro di sé e che, anzi, non si curerà affatto della presenza, delle richieste e degli avvertimenti dei noglobal.

Nel mezzo, ci fu un drammatico effetto collaterale: i vertici delle forze dell’ordine, tutti nominati dai governi di centrosinistra, in primis Gianni De Gennaro, capo della Polizia di Stato e capo in pectore del sistema di sicurezza del summit, capirono al volo che la loro posizione era in bilico. Il carro vincente chiedeva alla polizia un maestoso pugno di ferro: contro gli stranieri, la delinquenza e la piazza, vista sempre e comunque estremista. E quel pugno di ferro, i vertici di polizia e carabinieri, come se volessero accreditarsi, erano pronti a sfoderarlo in pieno, a qualsiasi costo.
D’altra parte, il governo Berlusconi non aveva il minimo interesse a conoscere, dialogare, trattare con il movimento. Detestava quei ragazzi, quelle donne, quei lavoratori. Persino il loro modo di vestirsi e pettinarsi. Il G8 non doveva subire nessun fastidio, anzi, doveva essere ancor più impreziosito da vasi fioriti e quinte sceniche. Questo irrobustì irrimediabilmente la postura intollerante che De Gennaro e gli altri avevano ormai inflitto alla polizia, dimenticando i sentieri illuminati della riforma del 1981 (la polizia garantisce i cittadini) a favore di un atteggiamento assolutamente militare e condito da una malcelata sensazione d’impunità. Un atteggiamento che avrebbe portato i poliziotti e i carabinieri a sentirsi chiamati, sulle strade di Genova, in una guerra contro un esercito nemico, dipinto come terrorista da una classe politica e da un sistema di intelligence in preda a un incontrollato isterismo mediatico.

I servizi segreti, da un lato avevano ben chiaro che a Genova sarebbero arrivate un paio di migliaia di devastatori black bloc: conoscevano i nomi e gli indirizzi di 1’439 individui pericolosi e diretti in Liguria. Ma nessuno li fermò. Dall’altro lato, scatenarono una ridda di voci che convinsero i poliziotti sulla malafede dei manifestanti, definiti armati di sangue infetto e di catapulte, capaci di sequestrare agenti, di sparare materiale pirotecnico sui blindati, intenzionati a mettere a ferro e fuoco, tutti insieme, la città. La situazione precipitò quando il governo Berlusconi decise d’innalzare una frontiera di ferro e cemento per sancire una zona rossa che dividesse la cittadella dei potenti dal resto del mondo. Una violenza barbara sui genovesi, che mai erano riusciti a percepire un confine persino nel mare, ora costretti a esporre il passaporto per rientrare a casa. La città era stata svuotata dagli allarmi e dalla paura, con tombini sigillati, forniture di sacchi mortuari agli ospedali e carceri svuotate per far posto a centinaia di possibili arresti.

I vertici delle forze dell’ordine furono completamente coperti da un governo sempre più disposto a garantire piena e visibile legittimazione, anche grazie a un esponente di spicco come Gianfranco Fini, che passò in rassegna le cabine di regia di polizia e carabinieri, pur non avendo né ruolo né competenze sull’ordine pubblico.
Eppure, i vertici del sistema di sicurezza riuscirono nella devastante impresa di sbagliare ogni mossa. Schierarono i loro uomini come fossero un esercito: ma la guerra non c’era, i soldati non erano mai stati formati per condurla e il teatro di battaglia avrebbe sconsigliato qualsiasi attacco. Evitarono volutamente di parlamentare con il movimento, consentendo agli spezzoni privi di briglie di reagire alle cariche e – drammaticamente – ad averne talvolta la meglio. Non fermarono mai i violenti, i casseur, i provocatori, i saccheggiatori, abbandonando completamente la città al suo destino (parole dell’allora sindaco Giuseppe Pericu). Colpirono, anzi, e senza motivo, gli spezzoni festosi dei cortei, i lavoratori, i pacifisti. Le suore!

E, questo il paradosso, spesso sbagliarono completamente la tattica. Come in via Tolemaide, quando i carabinieri allo sbando prima attaccarono illegittimamente i 25mila ragazzi dei centri sociali (giudizio dei tribunali) e poi si fecero mettere in fuga da brigate di straccioni, abbandonando furgoni blindati, estraendo almeno diciotto volte la pistola. Una rotta che inevitabilmente finì nella sacca di piazza Alimonda, dove un carabiniere fragile e incerto sparò in pieno volto a un ragazzo di vent’anni in fase d’assedio, senza neppure aver visto né il ragazzo né l’estintore che aveva tra le braccia. Il carabiniere era a bordo di un Defender che non doveva essere usato per l’ordine pubblico, ma solo per portare viveri alle truppe.
Era venerdì 20 luglio e se lo scontro di piazza poteva trovare schermo dietro la scellerata dichiarazione d’invasione della zona rossa da parte dei centri sociali, il 21 luglio questo canovaccio non era sul tavolo. Trecentomila persone volevano marciare per i diritti di tutti, senza la minima intenzione di sfiorare le barriere. Erano in maglietta e calzoncini, chiedevano solo di manifestare in pace. Saranno invece travolte da una serie di violente, inspiegabili e accanite cariche che spezzeranno il corteo e la quieta esistenza politica di migliaia di cittadini per bene. Con la scusa di duecento o trecento teppisti che si scagliarono contro le vetrine: e che nessuno tra le forze dell’ordine decise di fermare. Il governo Berlusconi giustificò in diretta tv ogni azione.

Ma non era finita. Ci fu la notte della Diaz, dove lo Stato prima si macchiò di un reato infamante attaccando nel sonno un centinaio di manifestanti innocenti e poi cercò di giustificarsi con una valanga di menzogne: come quella di aver messo apposta un paio di molotov per accusare quei ragazzi di terrorismo. “Dovevamo fare una montagna di arresti, perché la città era in fiamme e noi non avevamo neanche un fermato”, confessarono, poi, i vertici. Infine, ci fu Bolzaneto, la caserma dove lo Stato si inabissò nel peggiore dei reati, quello di tortura; tortura contro ragazzi arrestati senza motivo e innocenti. La Diaz e Bolzaneto gettarono un cupo cono di discredito mondiale sul governo: mondiale, sia chiaro. In Italia tutto era ormai preda del soporifero duello urlato della politica, incapace di qualsiasi analisi.
Fatti vergognosi come quelli della Diaz avrebbero preteso una seria, approfondita, neutrale riflessione in Parlamento. Immediata. In condizioni normali avrebbe portato a una ovvia, quasi indolore rimozione dei vertici di polizia e carabinieri, a un dibattito ampio e sereno sul ruolo delle forze dell’ordine. Secondo molti a una commissione parlamentare d’inchiesta. In Italia questo non avvenne. E così anche le ragazze e i ragazzi del Genoa social forum non riuscirono più ad alzarsi, lasciando che la lotta pacifica alle aberrazioni imperiali della globalizzazione, nata su radici progressiste, abdicasse alla lotta becera alla mondializzazione, imperniata oggi su capisaldi razzisti, populisti e sovranisti.

Incespicarono, in questa deriva, due poteri costituzionali dirimenti come la stampa e la magistratura. I media, accecati dal faro ricattatorio dei canali di proprietà dell’allora premier, non denunciarono con la veemenza necessaria la grave sospensione della democrazia. La magistratura, nonostante l’impegno quasi inspiegabile di un manipolo di pm, si lasciò logorare da perizie false, pressioni e intimidazioni. Pretendere una censura per i vertici di polizia e carabinieri non era un vezzo giustizialista: avrebbe anche restituito l’onore ai singoli agenti e ai singoli militari.
