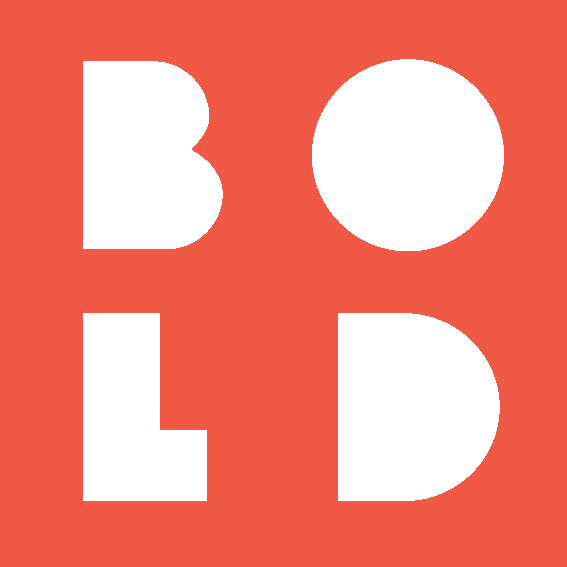
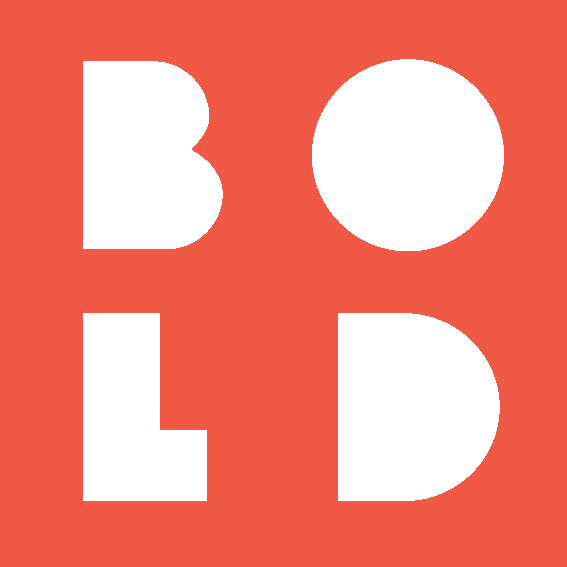
Dai salotti milanesi alla campagna parmense. Ma Verdi fu soprattutto una personalità europea, scrive il musicologo Carlo Piccardi
Una lunga vita, un lungo cammino. Il primo aspetto che spicca nell’esperienza di Giuseppe Verdi è senza dubbio l’ampio arco vitale (di quasi nove decenni), in cui si svolge un’evoluzione estetica e stilistica ragguardevole che vede il punto di partenza e quello d’arrivo lontanissimi uno dall’altro. Da Oberto conte di San Bonifacio (1839) a Falstaff (1893) si compie una parabola che di primo acchito non lascia riconoscere i termini come riferibili a uno stesso autore. Questo è già un rilievo che mostra com’egli si sia mosso con straordinario dinamismo nel flusso del tempo. Inoltre, se poniamo mente alle date dei suoi capolavori risolutivi (Rigoletto, 1851, Trovatore e Traviata, 1853), constatiamo che tale sua maturazione giunse intorno al quarantesimo anno di età, quindi assai in là rispetto ai punti d’arrivo arrisi ai compositori del tempo. Se fosse morto come Schubert (a 31 anni), Chopin (a 39 anni), Bellini (a 34 anni) – per non parlare di Rossini che, dopo il Guillaume Tell (composto a 37 anni) scelse di non più scrivere opere – di lui si tramanderebbe solo la memoria di un comprimario. Verdi rimane dunque un musicista problematico, la cui vicenda artistica si intreccia con l’epoca in un viluppo che lo vide accondiscendervi e opporvisi allo stesso tempo. Egli ebbe quindi bisogno di molto tempo per crescere.
In tale vasto arco temporale non si svolse solo il suo percorso personale, ma quello del cambio di paradigma dell’intera musica italiana. Cresciuto nella temperie del “bel canto”, i suoi primi lavori recano il segno di una tradizione che si reggeva su principi compositivi artigianali, della collaudata pratica operistica secolare, che nell’Ottocento si era popolarizzata in ambito borghese mantenendo la saldezza delle classiche forme del sontuoso canto spiegato di stampo aristocratico. In quella fase riconosciamo l’eredità di un’estetica melodrammatica saldissima ma facilmente ridotta a formule, capace di dar corpo ai valori del tempo con enunciazioni determinate, a sostegno del processo risorgimentale che si appellava ai principi morali, alla virtù, all’eroismo. Venuta a trovarsi contrapposta all’evoluzione della musica romantica dell’Europa nordica (tedesca in particolare), sempre più umbratile e sfumata nel profilo formale, la scelta era quella di arroccarsi a coltivare il suo riconosciuto primato belcantistico oppure di aprirsi, accettando di fare i conti con le altre esperienze continentali. È ciò che Verdi fece, soprattutto approfittando del successo che lo portò a Parigi, indotto a comporre nel solco del grand’opéra, confrontandosi inoltre con i nuovi modelli teatrali e letterari di Victor Hugo (Ernani) e di Schiller (Giovanna d’Arco, I masnadieri, Luisa Miller) e soprattutto di Shakespeare (Macbeth, seguito poi da Otello e Falstaff).
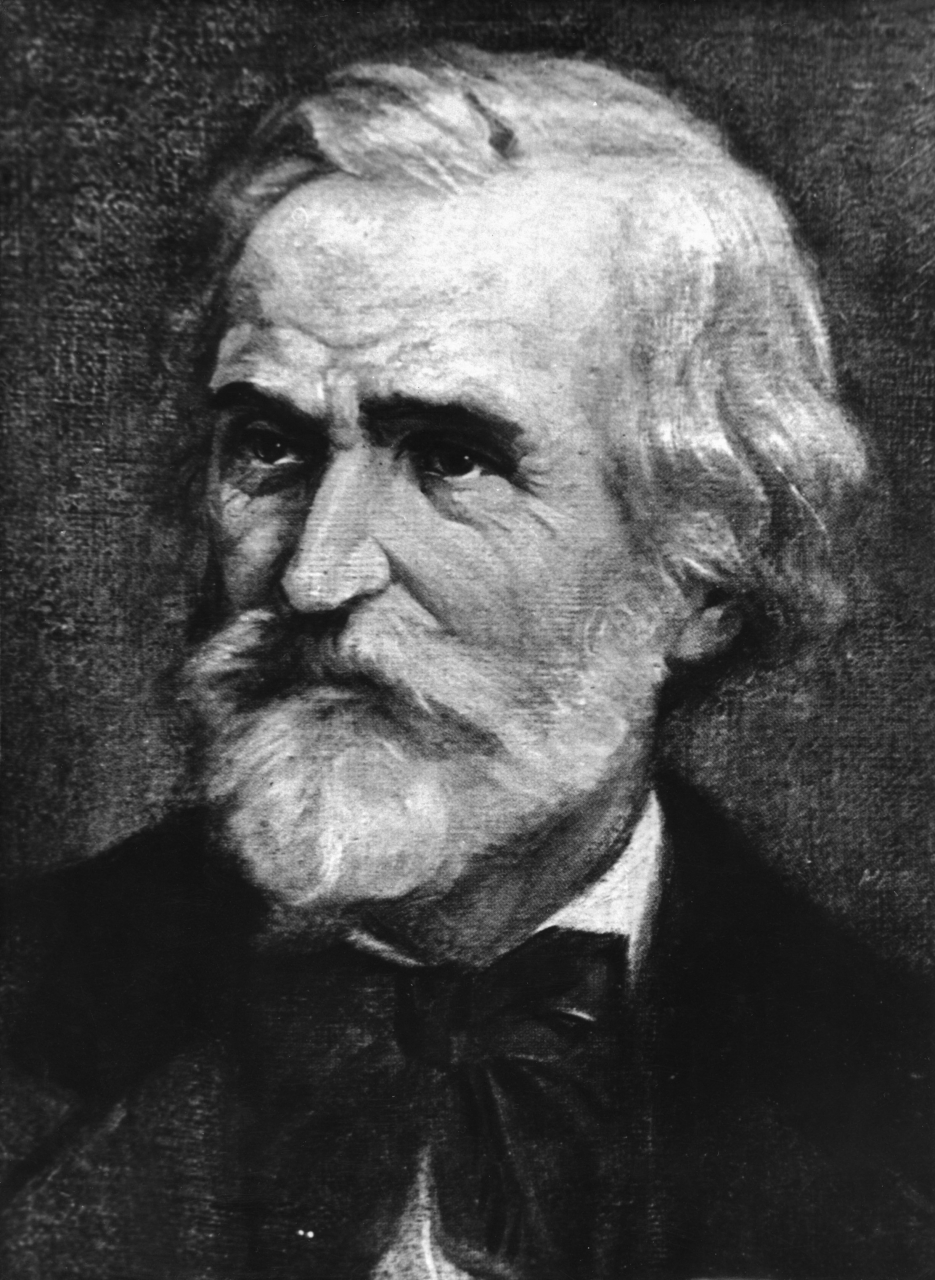
Raggiunta l’unità d’Italia Verdi si confrontò con una società dalle prospettive ambiziose, impegnata a misurarsi con le grandi potenze, spregiudicata, e dove la cultura metropolitana faceva già sentire la sua logica livellatrice del gusto, tendente a infirmare l’organicità del sapere. Porgendo attenzione ai modelli estetici delle altre tradizioni europee, egli si lasciò attraversare dal dubbio. Venne quindi il confronto con Wagner, la cui musica penetrò negli anni Settanta anche in Italia dopo avere conquistato il mondo letterario parigino. Nelle eteree dilatazioni melodiche di Aida (definita “il Lohengrin italiano” da Leone Fortis nel “Pungolo”) rileviamo la sua capacità di assimilare le innovazioni compositive e stilistiche dei contemporanei, consolidando il ceppo operistico di base, rimasto incrollabilmente italiano. Se per sovrappiù pensiamo alla sua modestissima nascita alle Roncole presso Busseto, figlio di un oste, l’ampiezza dell’arco di questa sua evoluzione appare impressionante. Oltre a liberarsi dell’impronta artigianale gravante sulla tradizione operistica italiana egli dovette infatti superare l’orizzonte della condizione contadina. In questo trovò sostegno nella frequentazione dei salotti milanesi, di quello della Contessa Clarina Maffei soprattutto, il cui marito Andrea mise al suo servizio l’esperienza di traduttore di Shakespeare e di Schiller.
La sua musica non mancò mai di presentarsi all’altezza del tempo riflettendone le contraddizioni, fino all’atto conclusivo della commedia shakespeariana (“Tutto nel mondo è burla”) che segna la sintesi disincantata, riconoscendo l’umanità come un nodo inestricabile di slanci generosi e di debolezze, di coraggio e di viltà, di esemplarità morale e di atti spregevoli.
L’italianità del suo sentire, diventata proverbiale, non deve far pensare a un artista arroccato nella sua statica identità. Verdi capì immediatamente che all’Italia dell’Ottocento, nonostante la nobile tradizione culturale (e nonostante l’irradiamento ancora vivo della sua tradizione musicale) non era più concesso il primato. Si adoperò quindi a cercare una via che integrasse il patrimonio d’origine alle nuove prospettive sorte in altri paesi in un’operazione che traccia un solco profondo tra la sua drammaturgia e le incerte prove dei musicisti italiani coevi. Egli fu soprattutto una personalità europea, dimostrata dall’inossidabile tenuta delle sue creazioni nei teatri di tutto il mondo ancora oggi, dalla vitalità di un’esperienza che, per il suo valore umano, è stata alla base dell’educazione sentimentale di molte generazioni.
Il fatto poi che, fino alla morte e nei tratti risolutivi, tale manifestazione di cosmopolitismo rechi ancora l’odore dei campi arati della campagna di Roncole, rivela come l’autenticità di un sentire conti nella misura in cui vibra sorretta dalla vitalità originaria.

È infatti significativo il fatto, all’apice del successo, di scegliere la residenza a Sant’Agata nella campagna parmense, a indicare il riconoscimento del legame con l’origine popolare e contadina, mai rinnegata e anzi coltivata allo scopo di approfondire la componente di veridicità del suo teatro musicale. È infatti a questa componente sostanziale che occorre riportare la franchezza espressiva dei suoi personaggi, la rudezza dei loro sentimenti accalorati, scolpiti come figure didascaliche a tratteggiare un’umanità che dà vita a vicende non solo coinvolgenti ma soprattutto esemplari nella contrapposizione dei valori positivi (amore, generosità, fedeltà, lealtà eccetera) a quelli negativi (malvagità, odio, empietà, invidia, codardia eccetera) in un’emblematicità profilata al punto da imporsi come un sistema di valori a cui riferirsi proverbialmente. In questo senso, se il teatro d’opera in Italia ha svolto la funzione di educazione sentimentale che nell’Ottocento in Francia era detenuta dal romanzo, Verdi ne è stato l’esponente che più ha inciso nella società e nel costume. Basti pensare alla Traviata, dramma borghese che si svolge nella contemporaneità, quindi non ‘in costume’, anche per mostrare come nell’opera non conti il differimento in luoghi storici e geografici lontani per inficiare la portata e l’intensità delle emozioni e dei sentimenti trasmessi sulle ali del canto.
Per di più il lavoro di Verdi non terminava con la consegna della partitura al teatro che gliel’aveva commissionata. La sua presenza durante gli allestimenti, non solo come direttore ma anche come regista, era un impegno risaputo, documentato anche da precise “disposizioni sceniche” diffuse dall’editore Ricordi, a testimonianza dell’importanza che il maestro assegnava a questo ruolo di verifica della volontà di assicurare il giusto impatto sullo spettatore. L’effetto scenico costituiva una componente chiamata a fare tutt’uno con la logica musicale, nel senso di ammettere anche la brutalità dei gesti (nel Trovatore) e la trivialità predisposta al fine di ottenere lo scopo (nel coro delle streghe in Macbeth) o il fatto di contestare la voce “troppo angelica” della Tadolini nel ruolo principale dello stesso lavoro al San Carlo di Napoli, pur di corrispondere alla necessità drammatica. In questo senso la natura della sua drammaturgia ha costituito un’eredità che il Novecento ha raccolto trasferendola nel cinema, che di quell’impianto estetico ha proseguito lo sviluppo, sia per quanto riguarda la veracità del fondamento psicologico dei caratteri, sia per la spinta all’azione attuata nel gioco dei contrasti, estremizzati sfidando l’omogeneità stilistica, aprendosi alle risorse del composito.