laR+ FestivaLLibro
Antonio Ligabue fra cinema e romanzo
Stasera al Palazzo dei Congressi di Muralto, con Renato Martinoni, Tania Pedroni e Giona A. Nazzaro
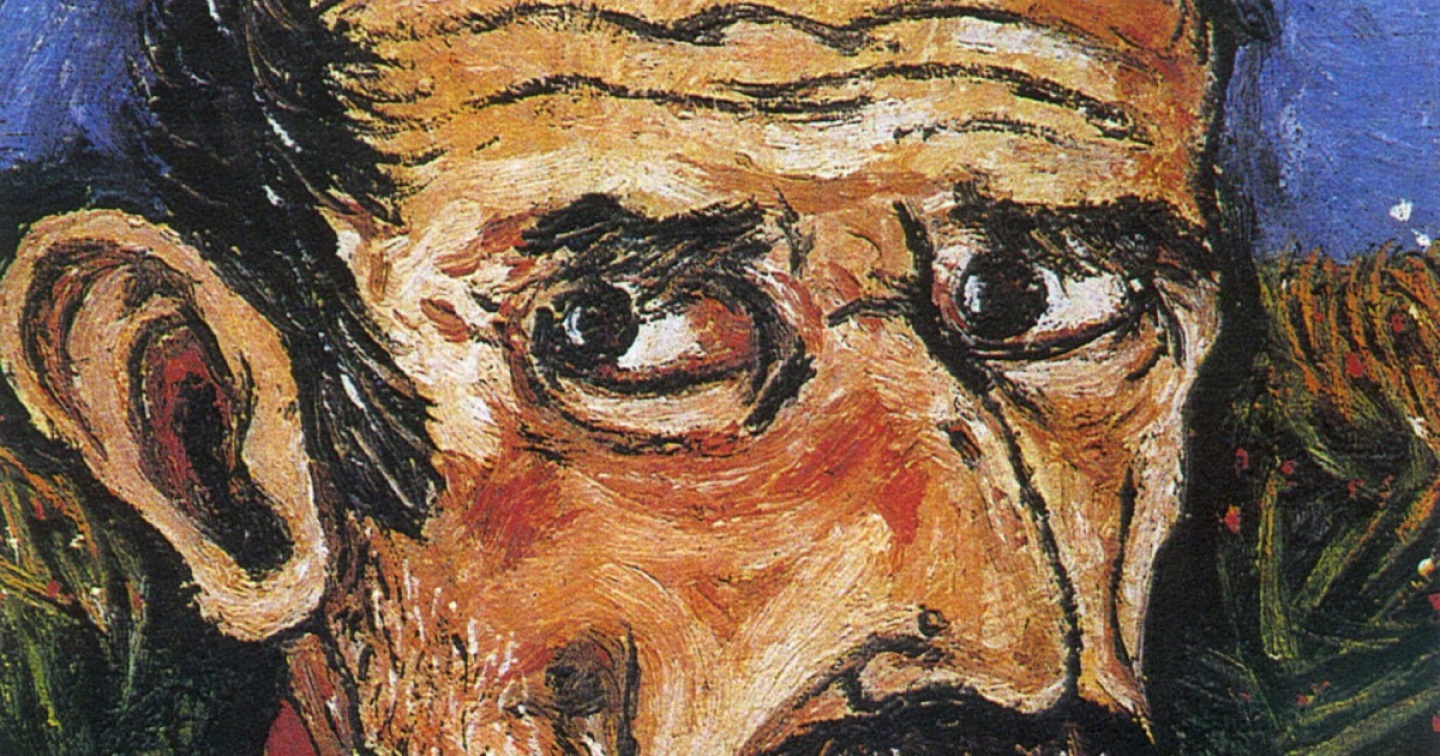
Antonio Ligabue, autoritratto
(Keystone)
29 aprile 2022
|
CULTURE