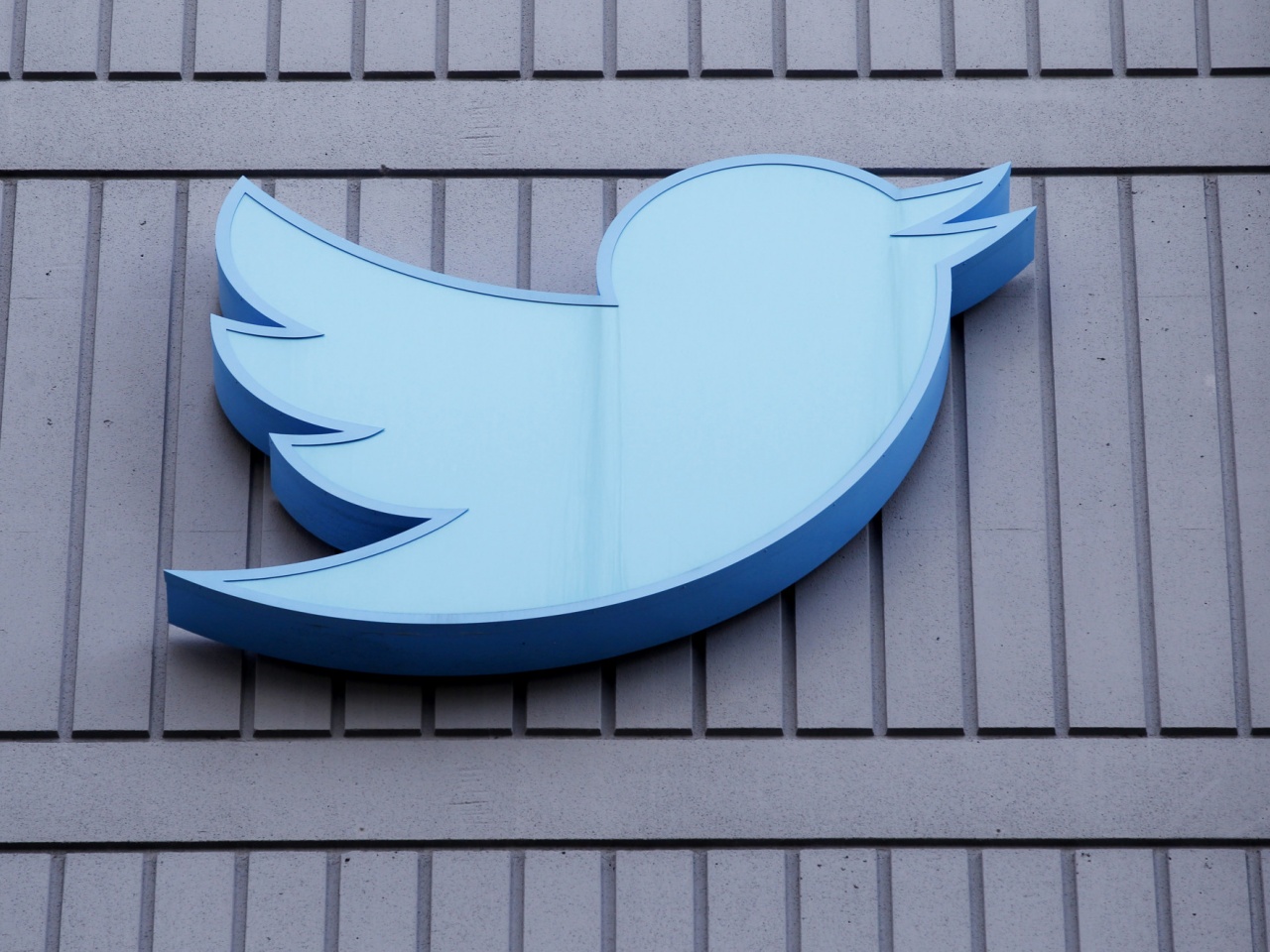Il mortale di Grancia? ‘Esempio di sconnessione dalla realtà’
All’indomani della condanna per omicidio colposo del 23enne, intervista allo psichiatra Michele Mattia: ‘I social vanno affrontati con spirito di critica’

«Sapevo che era pericoloso. Ma ero alla ricerca dell’adrenalina e del divertimento». Parole pesanti, quelle pronunciate in aula dal 23enne condannato ieri a Lugano. Parole pesanti, come pesante è da digerire la morte della 17enne Ketty, che si trovava a bordo di quella Volkswagen che sfrecciava incautamente zigzagando all’esterno di un centro commerciale di Grancia. Parole alle quali abbiamo cercato di dare un senso con l’aiuto dello psichiatra e psicoterapeuta Michele Mattia.
‘Il nuovo Dio è l’algoritmo’
«Viviamo in una società che vuole tutto e subito. E una società nella quale sono venuti meno alcuni elementi – osserva lo specialista –. Un primo elemento è la difficoltà, o quasi l’incapacità, a tollerare il sacrificio e quindi a rimandare il raggiungimento dell’obiettivo. Questo porta, attraverso tutte le tecnologie che abbiamo a disposizione, a una ricerca quasi spasmodica di stimoli che possano attivare il circuito adrenalinico. In un contesto nel quale in particolare i più giovani perdono i punti di riferimento tradizionali, legati ad esempio alla famiglia, soppiantati da persone che in definitiva sono dei perfetti sconosciuti, che creano o diventano loro stessi nuovi eroi da emulare. Sono le nuove divinità. Un recente studio sociologico dell’Università di Zurigo ha concluso che oggi, nel mondo dominato dai social, il nuovo Dio è l’algoritmo».
‘Si sottostima il pericolo’
Una prospettiva pericolosa però, considerato quanto imprevedibili siano gli algoritmi. «Assolutamente sì. E va considerato anche il fatto che quando siamo all’interno di questo sistema degli algoritmi, non riusciamo più a uscirne. In questo contesto si inseriscono i video che spopolano sui social, legati anche a corse scriteriate in auto, che, portando a una ricerca immediata dell’adrenalina, del piacere, conducono in definitiva a sottostimare il rischio. E questo è molto pericoloso. Freud teorizzava il ‘principio di realtà’: si viene a perdere il contatto con la realtà. E di conseguenza, manca anche la consapevolezza di quello che è il pericolo. Questa diventa un mondo etereo che passa attraverso le immagini, il video, lo schermo. Il paradosso è che ci scontriamo con la realtà quando capita qualcosa di grave».
‘La pandemia ha messo in evidenza problemi sociali esistenti ma meno visibili’
In questo distaccamento dalla realtà può aver contribuito anche la pandemia? Ricordiamo che nel febbraio del 2021 erano in vigore diverse misure contenitive. «Sicuramente la pandemia era un elemento coadiuvante, per il fatto che eravamo limitati nelle nostre libertà. In quei gruppi di ragazzi già predisposti alla fragilità ha sicuramente influito. È un cofattore che ha messo in evidenza una serie di problematiche sociali che precedentemente erano sotto soglia. C’erano già, ma erano meno visibili».
I social? ‘Vanno affrontati con spirito di critica’
Senza falsi moralismi, come far capire che queste cose non vanno fatte e che è davvero pericoloso farle? «Questi casi dovrebbero stimolare dei nuovi modelli di riferimento, legati a un confronto con un rischio reale che viviamo nella nostra quotidianità. In questo caso il modello era: ‘Io ce la faccio, perché sono superiore agli altri’. Il 23enne si era confrontato con delle analisi illusorie, che gli sono andate bene sette volte (ossia le volte precedenti che già aveva effettuato la corsa in auto in quel medesimo percorso, ndr). Ma in realtà si è rivelato un errore cognitivo. Si pensa di aver trovato la soluzione, ma non è così perché manca la consapevolezza». Il problema sono i social? «Non li demonizzerei. Viviamo in un ambiente digitale, i social e la tecnologia ci aiutano molto. Il punto è: come utilizzarli. Non devono essere il modello assoluto di riferimento, devono essere affrontati con capacità di critica, non dobbiamo mai perdere quest’aspetto di vista. I social non devono annullare la nostra capacità di analisi, è importante restare ancorati alla realtà».