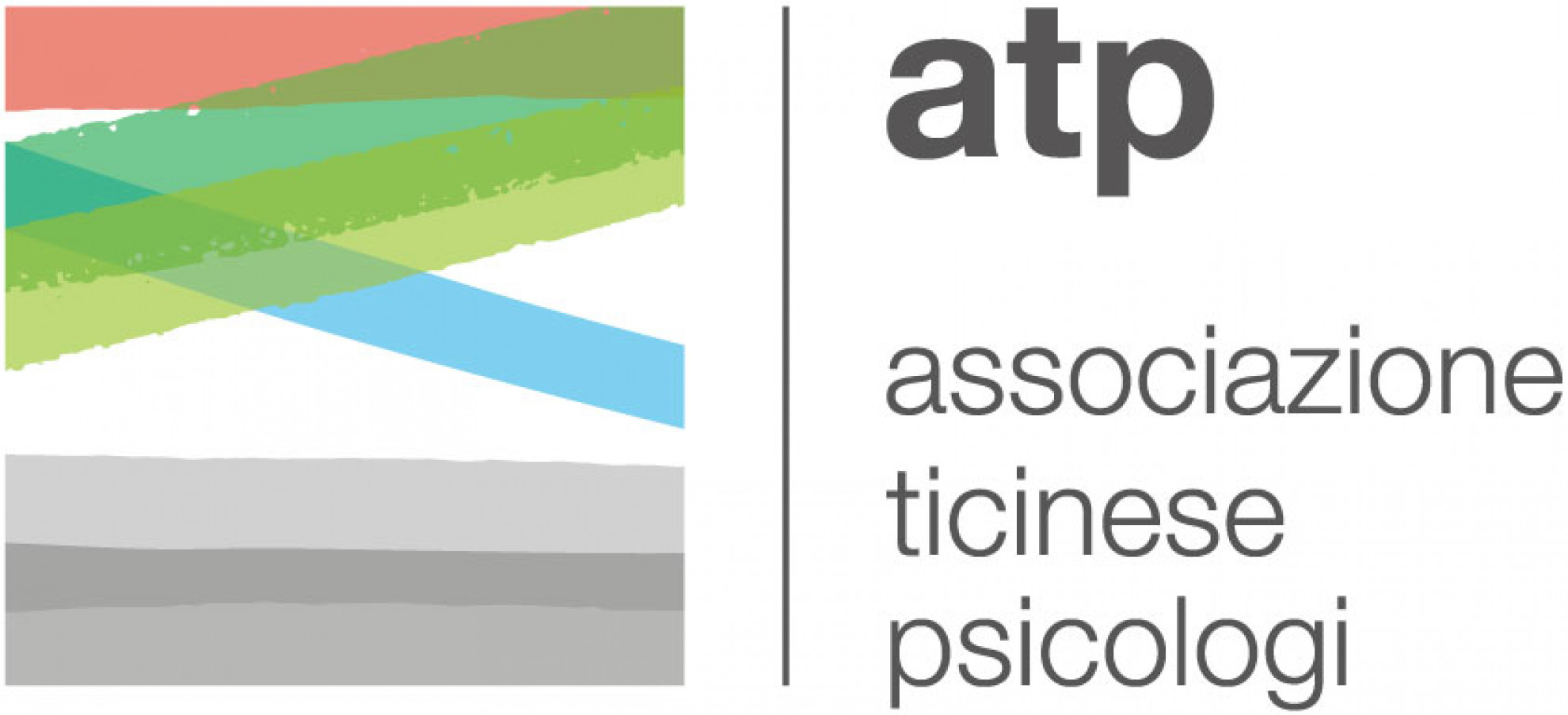Il pianto che parla di noi
Piangere non è da deboli né da bambini. È un processo che comunica agli altri il nostro bisogno di supporto. Accoglierlo e capirlo è importante

Le quattro del mattino. Mia figlia, tre mesi di vita, piange disperatamente, strilla inconsolabile. Maria Callas sarebbe sbalordita dalle quote raggiunte dai suoi acuti. Da un po’ di tempo a questa parte la bambina piange a orari regolari, quasi ininterrottamente, dalle dieci di sera alle 4 di notte. I medici le chiamano coliche del neonato. Infine, alle quattro di mattina, dopo che la mia compagna le ha provate tutte, tocca a me. Nel buio della stanza, con mia figlia in braccio, cammino (abbiamo fatto chilometri così), saltello, danzo, alla ricerca del ritmo e della posizione ideali, guidato dalle variazioni nell’intensità del pianto di mia figlia. Abbiamo speso ore e ore in questo modo, per svariati mesi.
Ad oggi, sono passati anni da queste scene, ma il mio stupore di fronte al comportamento del pianto è rimasto vivido: inevitabile dedicare una riflessione al pianto. Non bisogna lasciar perdere quei momenti e quelle lacrime nella pioggia.
Tra consapevolezza e protesta innata
Il pianto, si sa, è un comportamento congenito, iscritto nei geni. Era evidente per me come mia figlia non avesse fatto in tempo a impararlo, quando appena nata strillava con grande competenza. Ma perché? Il pianto come comportamento sembra avere un innegabile valore adattivo, motivo per il quale l’evoluzione naturale lo ha “salvato” e ci ha equipaggiato con esso. È un comportamento che si manifesta qualora il neonato rilevi uno squilibrio, uno scompenso delle condizioni ottimali del soma. Ad esempio caldo o freddo eccessivi, una posizione rischiosa o scomoda, stanchezza, fame; ovvero ogni volta in cui è persa l’omeostasi dell’organismo. Alla luce di questa riflessione il pianto appare come una sorta di spia atta a informare che qualcosa va fatto per ripristinare lo stato di quiete, per ritornare all’equilibrio organico. In questo senso potremmo dire, azzardiamo, che il pianto costituisce il primo passo verso un evento unico nella scala evolutiva degli esseri viventi: la soggettività. Il neonato sente sé stesso e comunica questo sentire.
Ciononostante a un osservatore qualunque non sembrerà che ci sia nessun “tempo” tra lo stimolo negativo o avversivo e la risposta di pianto, nessuno “spazio” e, dunque, nessuna consapevolezza: che non vi sia quello che chiamiamo mente o psiche in un neonato di uno, due o tre giorni di vita. È per questo motivo che il pianto del neonato è considerato un riflesso.
Tuttavia, possiamo senza indugi affermare che l’organismo protesta e vive intensamente sé stesso, che si sente e che comunica questo sentire (con sbalorditiva efficacia tra l’altro). Ma non solo, l’atto di piangere comunica anche la qualità di questo sentirsi e richiede l’azione dell’Altro. Notiamo, dunque, questo doppio valore del pianto. Dapprima il suo valore comunicativo e dunque sociale, che prevede e necessita la presenza di un altro da sé per compiere la sua funzione, per avere senso. In secondo luogo, il suo valore motivante: il pianto muove all’azione, segnala un’evenienza, situazione, pericolo ecc., ai quali bisogna porre rimedio; il pianto protesta un malessere ed esige un cambiamento. Grazie a queste prime constatazioni otteniamo qualche certezza circa le caratteristiche di noi umani. Siamo costitutivamente e inevitabilmente degli animali sociali. Nel nostro Dna sono previste e richieste sia la domanda di aiuto che la risposta attiva a tale richiesta. “Non esiste un bambino senza la madre”, direbbe Winnicott. Grazie al pianto, aggiungo, la soggettività ai suoi albori è accolta e informata.
Una lacrima dai mille significati
In tanti sappiamo cosa fare quando un bambino piange, e non c’è stato bisogno di nessuna lezione a scuola per farcelo imparare, è inciso nel nostro codice genetico, pulsa come tante altre conoscenze nelle nostre vene. Abbracciamo il bambino, usiamo la voce, il canto e i movimenti ritmici per calmarlo, cerchiamo di capire che cosa non va, lo riportiamo verso l’equilibrio dello stato d’animo; lo accogliamo, lo accudiamo, gli offriamo e confermiamo la base sicura dalla quale ripartire. Ma il pianto è essenziale non solo per il neonato e i bambini, è un comportamento basilare durante l’intero arco di vita di un essere umano. Come tanti comportamenti è soggetto alla caleidoscopica capacità umana di impiegare la stessa forma per svariati e diversi contenuti, così come per dare voce allo stesso contenuto attraverso le forme più disparate. Si piange per manipolare, gli attori lo fanno a comando, si piange di pura e profonda gioia, alcuni piangono senza lacrime, alcuni non “piangono mai”, taluni guardano di rado un film senza piangere almeno in un paio di scene. Comunque sia, la funzione originaria del pianto, quella di comunicare uno stato interno e mobilitare l’adulto, l’Altro da sé, all’azione per porre rimedio, rimane vigente e fondamentale. Questo comportamento fornisce un modello che resta essenziale per l’essere umano durante l’intero arco di vita, anche se non sarà più legato inestricabilmente al pianto e alle lacrime: il modello della richiesta di aiuto.
Distanza tra cuore e testa
I problemi che un adulto si ritrova ad affrontare sono alle volte di una ricca e sopraffacente complessità; problemi che hanno storie anche lunghe e contorte; problemi insidiosi e con radici remote, talvolta ereditati; problemi che crescono e si nutrono all’interno di una rete di ulteriori problemi: l’adulto può rimanere bloccato in uno dei numerosi nodi di questa matassa problematica.
Se questo adulto bloccato inizia a piangere, tale azione diventa una minuscola valvola di sfogo che allenta nel breve termine la pressione, come la sfiatata di una balena che esce in superficie a prendere aria prima di ritornare alle profondità. Ma difficilmente tale comportamento risolve la questione: il pianto, infatti, può non essere in proporzione con lo squilibrio sottostante. Ora, quella distanza tra il pianto e il dolore, squilibrio o problema che ci segnala, che nel neonato ci sembrava assente (il pianto come riflesso), è diventata enorme; lo spazio, la mente dietro al pianto (che supponiamo spieghi e causi questo) è sproporzionatamente lungo, largo, profondo. Il pianto non serve più a rappresentare il malessere e la sofferenza e la disperazione che un adulto può portarsi appresso. Paragonato col “pianto somatico” del neonato, ora i sentimenti sottostanti sono infinitamente più ricchi e complessi. Oltre al pianto, dunque, ci vuole la parola e la rappresentazione.
In altri casi l’adulto non può nemmeno piangere, ha perso la capacità di allentare la pressione e la sofferenza interne, e ha proprio bisogno delle parole e del racconto per recuperare questo accesso genuino e naturale alle proprie emozioni. Senza la messa in parole è difficile per l’altro da noi capire quando ci vuole un abbraccio, quando abbiamo bisogno di ritornare alla calma, di essere rassicurati, accuditi, accolti; quando abbiamo bisogno di ripristinare il senso di sicurezza di una base sicura alla quale tornare e dalla quale ripartire. Noi adulti abbiamo la necessità di saper formulare il nostro pianto, di articolarlo all’interno di un discorso, altrimenti i diversi pezzi della nostra sofferenza continuano a girare in noi, rimangono in circolo graffiandoci dall’interno come schegge di caos.
La naturalezza del cercare aiuto
Nell’età adulta, il pianto, la sofferenza e il malessere percepiti continuano ad avere quell’innegabile valore adattivo primigenio e genetico. Segnalando una realtà interna al soggetto, dando valore e statuto di realtà al proprio vissuto e alla propria soggettività, richiedono un cambiamento in noi, nell’Altro, nella realtà. Abbiamo visto che è del tutto naturale all’essere umano, del tutto necessario, comunicare questi stati e richiedere aiuto per riuscire a operare questo cambiamento: questo modello ci costituisce come tali, è previsto dalla nostra natura.
Ed ecco che, con o senza lacrime, il pianto può – e talvolta deve – essere trasformato in una domanda terapeutica, la chiave d’avvio di un percorso di psicoterapia. Lo psicoterapeuta, in effetti, attende il pianto del paziente con la pazienza del pescatore, che sia un pianto asciutto o ricco di lacrime. La spia che segnala il problema, il nodo, l’ingorgo: è lì che l’ascolto del terapeuta entra in scena come la rappresentazione dell’altro per il paziente. Un altro che sarà per un verso astratto, investito e condensato di tanti “altri” appartenenti alla vita e ai sogni del paziente; e dall’altra parte concreto, incarnato nella presenza di una personalità in maggiore equilibrio, che può accogliere e accudire i pezzi di sofferenza del paziente, reagire adeguatamente al suo “pianto”, aiutare a ritrovare la capacità di dare le lacrime e le parole giuste al malessere. La psicoterapia è, di fatto, in determinate situazioni, ingranaggio essenziale del ritorno all’equilibrio.
Non vorrei essere frainteso. La psicoterapia non è un lenitivo. In questo scritto la presento come lo strumento col quale poter affrontare il proprio dolore e integrarlo all’interno della propria soggettività, risolvendo i nodi e i blocchi che congelano la nostra naturale crescita personale. Il riconoscimento del nodo, la richiesta di aiuto e la successiva esplorazione collaborativa della personalità e della vita del paziente sono naturali e necessari come il pianto del neonato e le cure dell’adulto. Il racconto che una persona porta in psicoterapia, in modo analogo al pianto del neonato, ha il prezioso e inestimabile pregio di comunicare ciò che di più ricco essa ha: la sua esperienza, personale e soggettiva, la sua unica prospettiva di Sé stessa e il mondo che abita.
 DepositphotosPer sbrogliare il bandolo della matassa
DepositphotosPer sbrogliare il bandolo della matassaQualcosa di tutto questo aveva in mente il replicante del film Blade Runner (1982), quando prima di spegnersi (o morire?), lamentava “… e tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia”: lo psicoterapeuta è attento e curioso verso le lacrime e le parole del paziente proprio per non lasciar perdere quei momenti, per impedire che quelle lacrime si confondano con la pioggia, significandole e collocandole all’interno della fitta rete di senso che compone la nostra soggettività.
In collaborazione con