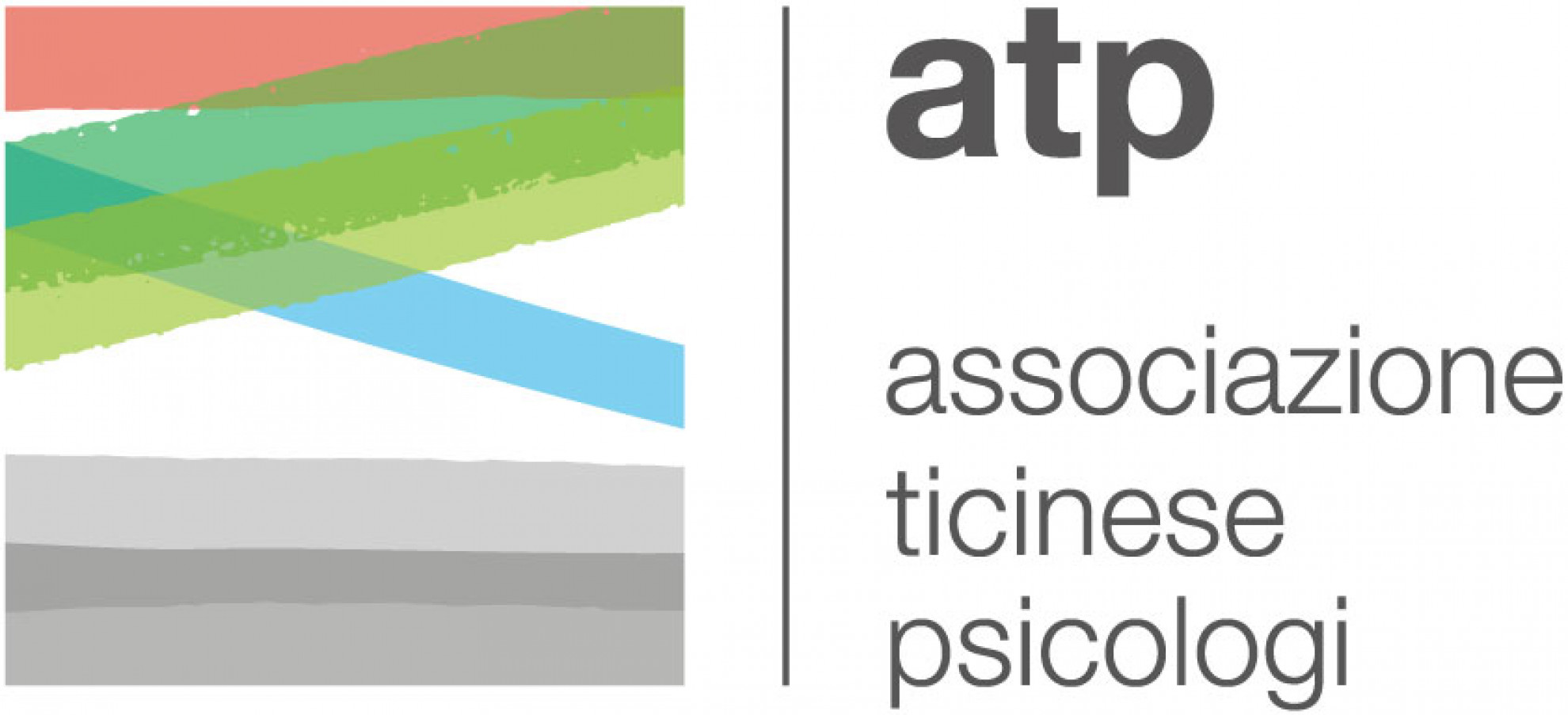Il fragile ‘limite’ degli adolescenti
Il difficile confronto della nostra società con i limiti ci ha portati a percepirli in maniera negativa, dimenticando però così la nostra dimensione umana

J. Egan, scrittrice americana, ha coniato il termine parole-bossolo in alcuni suoi romanzi ambientati in un futuro prossimo, a metà utopico e a metà distopico. Tali parole sono termini eviscerati, ormai morti e freddi: involucri verbali, sgombrati dal loro significato e utilizzabili solo tra virgolette, come gusci ormai vuoti che possono prestarsi a fare da meri contenitori, duttili e malleabili. Nel romanzo, sono diventate bossolo parole come americano e democrazia: termini che in quel futuro sono diventati maliziosi, ironici, significanti tutt’altro.
Riflettendo sulla questione, ci si può rendere conto di come essa sia meno immaginaria di quanto sembri. Le parole e le frasi-bossolo permeano anche la nostra quotidianità, con ripercussioni concrete e di capitale importanza. Il linguaggio, infatti, è lo strumento con il quale costruiamo noi stessi, le nostre relazioni e la realtà che ci circonda; è lo strumento che ci permette di avere un passato e un futuro, di immaginare e creare, di definire e definirci. Chinarsi sulle parole e sul loro uso, dunque, è una questione che esula dalla mera speculazione intellettuale per fondarsi concretamente nella realtà della vita quotidiana.
Verso l’infinito e oltre
Oggi, la parola-bossolo per eccellenza è limite. Tale parola, a livello individuale, ha perso il suo significato originario ed è diventata quasi una parola oscena, da non pronunciare e da aborrire. Il limite nella nostra società è diventato sinonimo di fallimento e insuccesso, un difetto, un impedimento o una barriera da superare a tutti i costi: lo sviluppo tecnologico va in tal senso e sta sempre più disabituando le persone ad avere degli umani e organici limiti. In tal senso, anche la medicina occidentale spinge sempre di più a eludere il limite: la morte è una sconfitta, qualcosa da nascondere e da procrastinare illusoriamente all’infinito. Siamo immersi nella cultura del “se vuoi puoi” e dell’andare oltre, che invita a ignorare e allontanare ogni cenno di limite personale (fisico, mentale, lavorativo).
Anche a livello collettivo, tale termine è diventato un bossolo contenente un proiettile diverso dall’originale: se, individualmente, ogni accenno di limite va sconfitto, cancellato, spostato e disprezzato, a livello gruppale e macro-sistemico si assiste sempre di più a un’apologia dei limiti: territoriali, politici, spaziali, culturali. Esso diventa, così, sinonimo di protezione e difesa, mettendo sul piatto tutte le derive fobiche del caso.
La sottile linea tra cielo e terra
La parola limite etimologicamente deriva da due termini latini, limen e limes, che racchiudono in loro tutta la potenza dell’ambivalenza di tale significato: il primo, rimanda a principium (quindi alla soglia, che consente il passaggio e la comunicazione); il secondo a terminus (quindi al confine, alla separazione). In tal senso, dunque, il limite è qualcosa che mette in contatto separando, che separa mettendo in contatto: una linea di demarcazione che include ed esclude, avvicina e allontana; una soglia che può essere varcata oppure allontanata.
Per affinità semantica, si può accordare anche una derivazione greca a tale termine: horos, cioè il confine, inteso anche come criterio e norma, fondamentale in quanto garante dell’ordine (le regole permettono di definire il caos, di renderlo ordinato). Fissare un limite-confine, infatti, significa consacrare l’alterità e la sua esistenza, normare e definire una differenza, regolamentando il rapporto con essa. Nel mondo antico, il confine è nientemeno che l’originaria distinzione tra Cielo e Terra: senza la definizione di tale limite, nulla avrebbe potuto essere creato, avere un nome e un’identità. Il limite è, quindi, il principio ordinatore del mondo e lo strumento che l’uomo utilizza fin dall’inizio dei tempi per tenere a bada la propria paura: l’infinito, infatti, attrae e atterrisce, va conosciuto per poterlo delimitare, per prenderne possesso, per sentire di averne il controllo e non rischiare di venirvi inghiottiti.
Mettere dei limiti, avere dei limiti, è ciò che permette di contenere e di mettere in forma; quindi di ordinare e conoscere, di pensare e pensarsi.
Dove finisco io, inizi tu
Il proiettile originario del bossolo-limite, dunque, ci parla di apertura, di ingresso, di confronto ordinatore, di linea di demarcazione che segna la fine di qualcosa o qualcuno e l’inizio di qualcos’altro o qualcun altro, sempre e comunque a me vicino.
Confrontarsi, dunque, con i limiti vuol dire prendere coscienza della propria umanità e di quella altrui; pensare fino in fondo concetti e apprendimenti; imparare a rispettare le proprie e le altrui linee di confine, valorizzando il più possibile tutto ciò che sta al di qua e al di là di tali confini. Infatti, nella sua accezione originaria, il limite è qualcosa che seppur sempre delimitato è insieme aperto: non è una porta serrata tra noto e ignoto, tra dentro e fuori; bensì un luogo di passaggio che può essere attraversato con l’aiuto del sopraccitato vicino.
Vergogna, fallimento e colpa
Nulla a che vedere con il concetto di fallimento o di diagnosi che la nostra società gli ha sovrapposto. La fragilità sempre più dilagante tra i ragazzi o gli episodi di aggressività e di assenza di rispetto dell’alterità segnalano, tra le altre cose, il sentimento di frustrazione e impotenza che queste generazioni non riescono più a mentalizzare e sopportare. Lo scontro con il limite non avviene più secondo i parametri originari: non è interrogazione e ponderazione sul sé e sul proprio corpo, sulla propria e l’altrui potenza, sull’ordine e la confusione; bensì vergogna e fallimento, colpa e inutilità, paura dell’insuccesso e sensazione di soffocamento.
Per non essere dei falliti, per non incappare in qualche etichetta diagnostica, è necessario riuscire in tutte le materie tutto l’anno, così come nelle relazioni e negli interessi; pena l’imbarazzo e la vergogna, la necessità di nascondersi o di nascondere che si è un insuccesso.
Bisogna sempre andare oltre e ignorare le linee di demarcazione: così facendo, però, si finisce per insegnare a ignorare non solo i propri confini, ma anche quelli altrui. Fare e farsi del male diventa qualcosa di banale, di poco pensato e simbolizzato. Fallimento e realizzazione vanno inseriti in una diversa narrazione: non più sinonimo o contrario di limitato, bensì le due facce della medaglia della potenza (intesa come contrario dell’impotenza/onnipotenza), unica dimensione che permette l’Essere proprio perché confinata, delimitata e condivisa.
Dal mancato senso, al caos
Tale deriva ha queste importanti ripercussioni soprattutto sulle fasce più giovani della popolazione e sul modo in cui vengono educate, poiché l’età che, per eccellenza e per definizione, ha a che fare con il tema del limite è proprio l’adolescenza. Non è un caso, dunque, che proprio all’interno del sistema scolastico possiamo ben intravedere i mutamenti che lo svuotamento del significato originario della parola limite sta comportando. La scuola, infatti, è l’ambiente primario di vita e socializzazione: in essa i ragazzi apprendono sia a livello cognitivo e culturale, che a livello relazionale, emotivo e dell’identità personale. Ed è proprio all’interno di tale contesto che il bossolo inerte di limite è stato riempito da altri proiettili, diversi da quelli originari e molto più pericolosi. Come già accennato, il limite anche all’interno del contesto scolastico è diventato sinonimo di fallimento e insuccesso, oppure indicatore di diagnosi (disturbi specifici dell’apprendimento, deficit dell’attenzione e disturbi d’ansia sono tutti in notevole aumento tra gli studenti). Il limite è, quindi, qualcosa di negativo; nel primo caso va punito, nel secondo invece curato, ma in entrambi i casi, comunque, smascherato, superato, ignorato.
Scorrendo le notizie dell’anno scolastico terminato a giugno, si incappa principalmente in due filoni di avvenimenti: studenti che sparano proiettili di gomma alla docente, che picchiano i maestri o che li minacciano con il coltello da un lato; ragazzi che si tolgono la vita per non aver superato gli esami, licei che aboliscono la votazione numerica a causa dell’ansia e della fragilità degli alunni (a Venezia), ritiri scolastici e isolamento sociale dilagante, dall’altro lato.
Tornare a insegnare il vero significato di limite
Entrare nell’adolescenza significa dover affrontare due grandi lutti: quello dell’illusione della propria immortalità e quello dell’onniscienza e onnipotenza genitoriale. In altre parole, la pubertà è lo scontro frontale con i limiti: la morte, l’impotenza, la confusione. I ragazzi devono instaurare nuovi processi di simbolizzazione e una nuova rappresentazione del proprio corpo (mortale e, ora, sessuale), fare i conti con la delusione e la frustrazione di non poter esistere in modo onnipotente, bensì “solo” in modo potente. In altre parole, gli adolescenti si ritrovano ad avere a che fare con il significato originario della parola limite, ma in un contesto nel quale tale significato non è più racchiuso nel suo involucro. I ragazzi sono costretti nella morsa della negazione della morte senza poterla usare come concetto cardine per accettare la fine, il limite, dando così valore profondo alla vita e allo scorrere del tempo: la morte viene esclusa – anche attraverso agiti auto ed etero aggressivi – all’interno di una narrazione comune che alimenta tale angoscia.
Il sillogismo è semplice: non può esistere l’Essere senza limiti, se i limiti vanno negati, odiati e distrutti, allora è l’Essere stesso che va disprezzato e mortificato.
Il limite, dunque, va insegnato e valorizzato: bisogna pensarlo e osservarlo perché è proprio tale linea che consente e permette la vita, la crescita, l’esistenza.
Educare gli adolescenti al limite significa accompagnarli dentro e fuori la soglia, attraversando noi stessi in continuazione gli inizi e le fini, tollerando assieme a loro il terrore dell’ignoto e assaporando la forma conoscibile del noto. L’esperienza (dal fallimento alla realizzazione, dal successo alla frustrazione), proprio in quanto limitata e finita, sarà così vissuta e valorizzata, rispettata e approfondita.
In collaborazione con