laR+ IL COMMENTO
L’eroe morto, la bambina respinta e altri racconti di cecità
Non è chiaro a cosa sia dovuto l'obnubilamento di cui è afflitta una parte della società israeliana (e non solo): per ora si contano soltanto le vittime
In sintesi:
- Sábato e Saramago hanno deciso di affrontare la questione della cecità
- Lo stato di smarrimento collettivo israeliano può condurre a tragici e assurdi episodi
- Qualcosa di simile alla cecità pare stia colpendo pure buona parte dell’Occidente
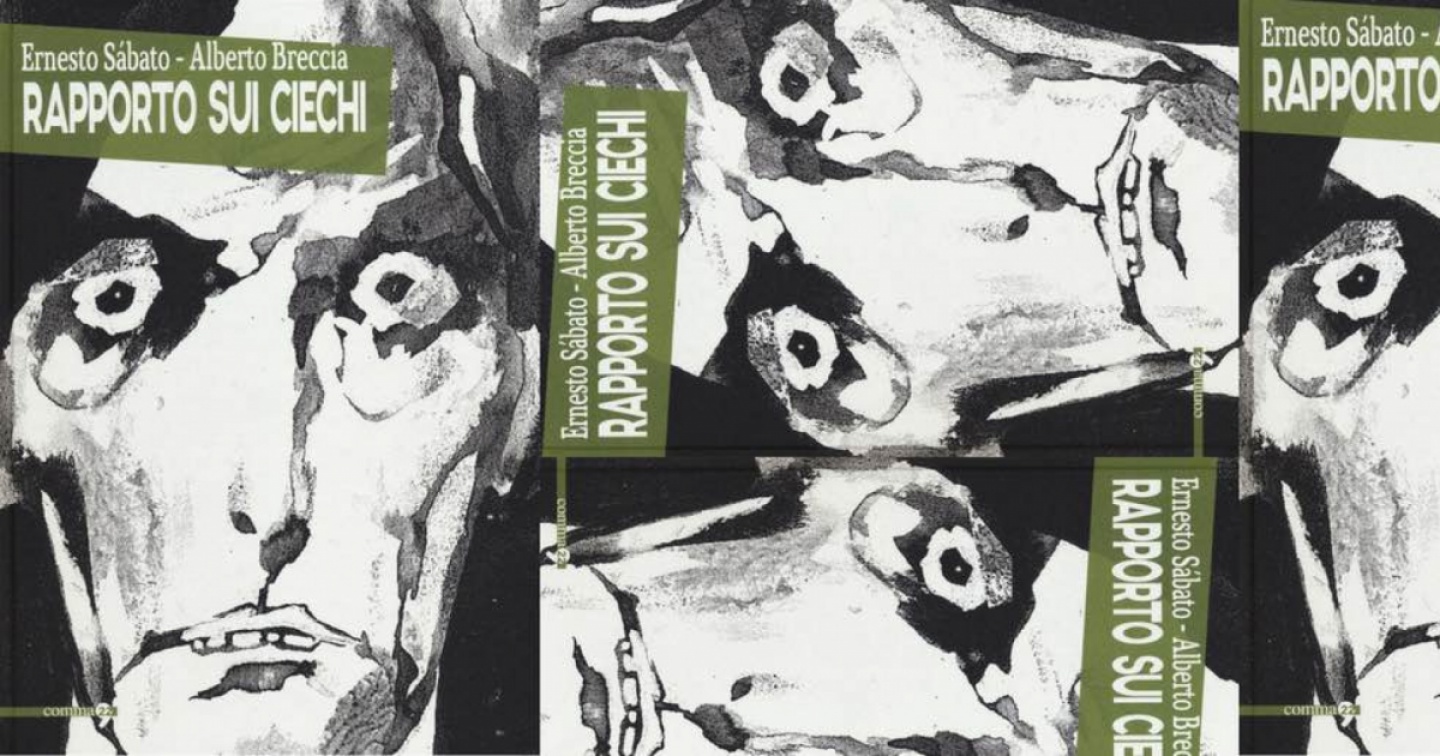
9 dicembre 2023
|



