laR+
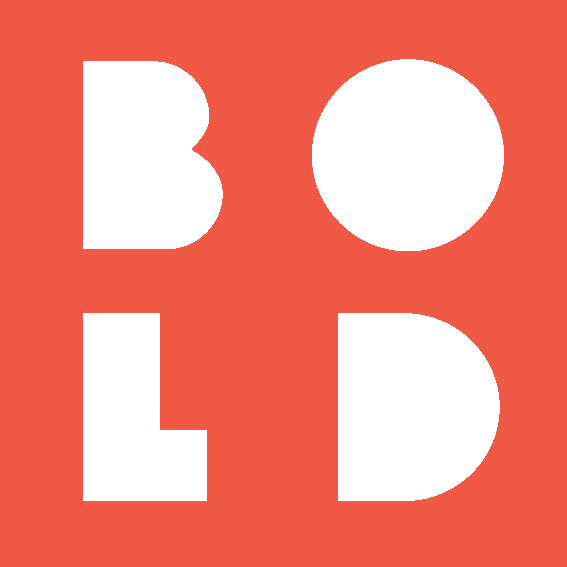
Dal ritiro al ritorno alle gare. ‘Ma non chiamateli patetici’
Nella lista dei grandi rientri nello sport si sono aggiunti Vonn e Hirscher. Cosa spinge un campione a riprovarci? Ce ne parla lo psicologo Giona Morinini
Lindsey Vonn e Marcel Hirscher con le rispettive coppe della classifica generale nel 2012 (Keystone)