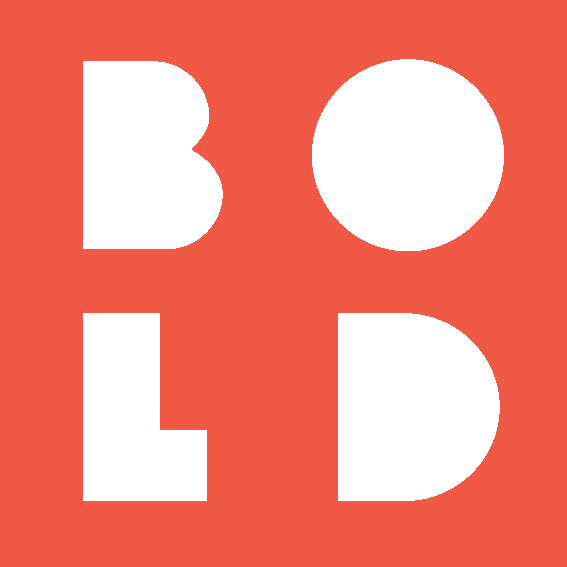
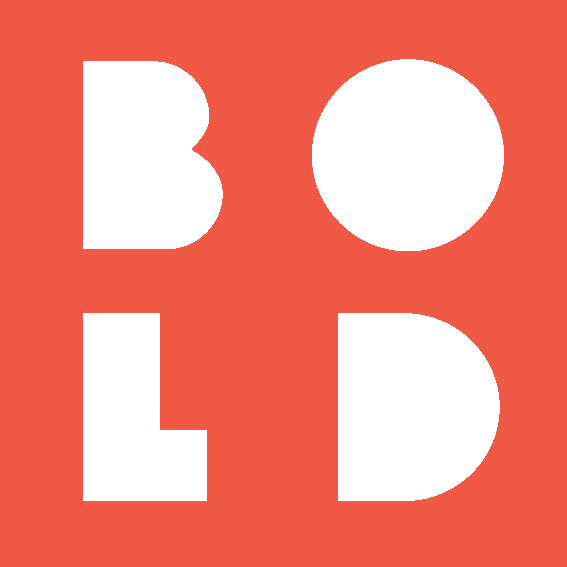
Melanie, Nicole e Rachele raccontano l’inferno dell’autolesionismo. Più casi in psichiatria di giovanissimi che si feriscono per far uscire l’angoscia
Armati di lametta, vanno in bagno e di nascosto si tagliuzzano braccia e gambe. Scacciano il dolore col dolore: «Faceva male, faceva bene. Appena vedo il sangue uscire, anche l’angoscia esce fuori, passa la rabbia, passa l’imbarazzo, ma poi mi sento in colpa». Malgrado la vergogna, Melanie, Nicole e Rachele hanno trovato il coraggio di parlarne sul nostro giornale, ci aiutano a capire il ‘cutting’, come lo chiamano gli esperti, un inferno invisibile, ma purtroppo sempre più diffuso, che preoccupa gli psichiatri. Mi faccio male per non sentire il vuoto, per punirmi, per scaricare la rabbia. La pelle diventa un foglio su cui disegnare la propria sofferenza. C’è chi nasconde le cicatrici con maniche lunghe. C’è chi le esibisce, come un guerriero della mente. Tutte sono state ricoverate alla clinica Santa Croce dove hanno iniziato un percorso di cura. «Assistiamo 3-4 giovani ogni settimana, è un fenomeno in aumento che ci preoccupa», dice la psichiatra Sara Fumagalli direttrice sanitaria della struttura di Locarno.
La storia di Melanie
«Vedi queste cicatrici..., raccontano la mia storia. Quando sto bene, le guardo e sono fiera del coraggio che ho avuto. Sono ancora qui», mi dice Melanie Diserens, 21 anni, mostrandomi i suoi avambracci. Ci incontriamo in un bar a Locarno. La sua voce è ferma, il suo sguardo piantato nel mio. Si apre con schiettezza, tuffandosi nel suo doloroso passato per riportare in superficie pezzi di vita. «La prima volta che mi sono fatta male avevo 13 anni, mi sentivo esplodere, tanta era la rabbia che avevo dentro. Era un dolore insopportabile, tagliarmi lo rendeva più gestibile, lo faceva diminuire, era come farlo scorrere fuori assieme al sangue», spiega scegliendo con cura ogni parola. È una ragazza alta e ben radicata. Da piccolina era sicuramente la più alta della classe. «Sì e mi prendevano in giro per questo e perché venivo dalla Svizzera francese. Mi vedevano come un’estranea». Dai 9 ai 16 anni, Melanie (nella foto) ha vissuto a Ponto Valentino, aveva pochi amici e in casa c’era tensione tra i genitori. «Ero molto sola, non avevo quasi amici e non mi sentivo al sicuro a casa mia. Mi tenevo tutto dentro. Soffrivo di sbalzi d’umore, di ansia e avevo attacchi di panico. Mi tagliavo le braccia e nascondevo le ferite con maglie a maniche lunghe. Mia madre non si è accorta di nulla», precisa. Aveva 14 anni ed era molto brava a scuola. Poi è iniziato il mal di schiena, era talmente forte che l’ha bloccata un anno a letto. «Pensavano fosse psicosomatico, i medici mi dicevano che era l’ansia. Mi sembrava di impazzire a restare 24 ore su 24 a letto, paralizzata dal male». Più tardi, gli specialisti scoprono che soffre di spondilolistesi (ossia lo scivolamento di una vertebra lombare rispetto alla vertebra sottostante). Provata nel corpo e nella mente, viene ricoverata all’ospedale Civico a Lugano per disturbi psichiatrici. Dopo tre mesi, inizia una nuova vita in un istituto a Tenero, dove l’aiutano a finire gli studi e rendersi indipendente. «Il mio sogno è fare l’attrice» mi confida. Di tanto in tanto tiene spettacoli con bolas e catene infuocate. Una sorta di giocoliera tra le fiamme. Sul suo braccio sinistro c’è un tatuaggio con un cuore in fiamme. «Mi rappresenta bene, ogni emozione mi brucia, la sento amplificata nel bene e nel male».

Il fondo, come dice lei, l’ha toccato durante il lockdown nel 2020, quando nel suo appartamento si è ritrovata sola. «La situazione ha risvegliato in me il periodo che ero bloccata a letto, scatenando molte paure. Avevo crisi di ansia molto forti, faticavo a seguire le lezioni e ho ripreso a ferirmi, arrivavo a farlo tutti i giorni», racconta. A peggiorare la situazione si aggiunge la separazione dei suoi genitori, che lei vive come un abbandono. Una bomba esplode dentro Melanie. Le sembra di convivere con un demone chiuso nella sua testa. «La cosa peggiore era che pensavo di meritarmi tutto quel dolore e più di una volta ho pensato di farla finita». Iniziano i ricoveri (tre in tutto) alla clinica Santa Croce ad Orselina dove le viene diagnosticato un disturbo della personalità borderline. «È stato un sollievo sapere che ero malata e non era tutta una mia invenzione». Melanie riesce a dare gli esami e finire la scuola commerciale. Dai momenti più bui sono passati 7 mesi, oggi Melanie ha un compagno, non si ferisce e ha deciso di occuparsi della sua salute. Segue un corso alla clinica Santa Croce per capire quali pensieri scatenano le sue crisi e come gestirle, condivide le sue esperienze su Tik Tok, ha un lavoretto. «Vedo i progressi e sono contenta», dice prima di lasciarci. La borsa a tracolla e via, se ne va in palestra. Osservo la sua camminata sicura, di chi ha imparato, un passo alla volta, a rialzarsi con coraggio.
La testimonianza di Rachele
Rachele, 22 anni, mi mostra il suo diario, ci sono annotati i pensieri più intimi, quello che prova quando arriva una crisi che la obbliga a tagliarsi; vedo dei post-it colorati che segnano i passaggi più importanti, uno è rosa come i suoi capelli, mi legge quella pagina. «Non escono le lacrime, non esce il dolore che mi opprime il petto, mi sento imprigionata in un corpo e una mente malati. Mi taglio, mi brucio, sfrego le mani contro il muro, per far uscire quel dolore. Sto meglio per un momento, ma allo stesso tempo non voglio guarire, perché come paziente qui mi sento accolta e capita. C’è chi si occupa di me». Il mondo fuori fa paura, la clinica diventa un sicuro rifugio. Incontro Rachele alla clinica Santa Croce di Locarno dove è ricoverata per un tentativo di suicidio. Mi offre, come benvenuto, un mini cake al cioccolato, ci sediamo in una saletta. Aprirsi le costa fatica. Vuole farlo come atto di solidarietà verso chi soffre come lei. «Fammi parlare, se hai domande mi interrompi», dice col timore di cambiare idea e tornare in camera sua. La sua voce è calma, tutto in lei esprime una grande pacata dolcezza.
Malgrado i voti alti, non ha terminato il liceo. «I docenti mi dicevano se non passi tu non passa nessuno. Non capivano che io non reggevo lo stress degli esami, avevo continui attacchi di panico». Non completa gli studi e si trova un lavoro. Va per un po’, poi esplode l’angoscia, la pandemia accentua forse un malessere sempre più pesante. Con sua madre i rapporti sono difficili. «Lei lavorava e da piccola ero spesso a casa da sola. Non avevo un dialogo con lei, ora sto provando a costruirlo». Dopo un primo tentativo di suicidio finisce in clinica. Ne esce e ci riprova. Ora è alla Santa Croce. «Quando sono nella crisi più nera non so come chiedere aiuto. Nel migliore dei casi mi taglio, nel peggiore vado oltre».
Indossa una maglia a maniche corte, osservo le sue braccia solcate da ferite e bruciature. Sono lì a testimoniare il suo percorso di guerriera. Se ne accorge. «Mi copro, se ti infastidisce», dice. Non sono infastidita ma rattristata da tanta sofferenza. «All’inizio mi coprivo, per evitare il giudizio degli altri, per non dover dare spiegazioni». In clinica nessuno fa domande indiscrete. Tutti sanno, tutti capiscono; tutto è più semplice. «Ho iniziato a tagliarmi durante un ricovero nei momenti più difficili. Vedevo il sangue e mi calmavo. Volevo trasportare nel corpo, quell’insopportabile dolore mentale». Coi genitori non riusciva a parlarne. «Non sono mai riuscita a farlo. È un’amica infermiera che mi ha convinto a chiedere aiuto». Rachele è in una fase delicata del suo percorso. Davanti a sé ha un periodo in un foyer. «So che è difficile comprendere perché una persona si ferisce. Avevo una compagna di scuola che lo faceva. A quei tempi, anche io, non capivo». Prima di lasciarci riapre il suo diario. Legge un altro pensiero: «Mi odio, mi disprezzo, arriverà mai la pace per me». Mi spiega: «Nel mio dolore io mi sentivo sola. Ero arrabbiata, mi sentivo in colpa e mi facevo male». Rachele ha iniziato un percorso di cura di gruppo, dove imparare strategie diverse per placare la sua angoscia di vivere.
«Odiavo me stessa, volevo farmi male, perché pensavo di meritarlo. Quando ero molto triste e tanto arrabbiata mi tagliavo le braccia fino a far uscire il sangue, mi sembrava di allontanare anche la sofferenza e sentivo meno ansia», ci racconta Nicole C., 21 anni.
Indossa una maglietta nera con maniche corte. Sulle sue braccia sono ben visibili le cicatrici, alcune superficiali, altre più profonde. È la sua mappa del dolore, non la nasconde. Il suo sguardo è calmo quando mi confessa: «È come una droga, appena ti senti male vuoi sfogarti con una lametta. Appena lo fai ti senti meglio, ma dopo dieci minuti ti accorgi che non è giusto, i tagli bruciano, devi mettere delle bende e l’angoscia è ancora lì». Ripercorriamo insieme la sua adolescenza. Al primo taglio aveva 14 anni. «Soffrivo di crisi depressive e attacchi di panico, l’adolescenza è stata un vero inferno, non mi sono goduta la mia età».
La scuola per Nicole è un lungo calvario. Mi dice che la bullizzavano e i numeri le facevano venire il mal di pancia: «Alle Medie la docente di matematica mi prendeva di mira, non riuscivo a fare calcoli semplici e mi diceva davanti a tutta la classe che ero una fallita. Io non sapevo come difendermi». Più tardi alla giovane viene diagnosticato un problema di discalculia. «Ho iniziato a soffrire di attacchi di panico, prendevo ansiolitici, ma presto ho perso il controllo». Dall’uso, Nicole scivola velocemente nell’abuso delle pillole per lenire l’ansia e le crisi.
La madre è molto preoccupata, vede i tagli sulle braccia di Nicole, legge la sofferenza della figlia sempre più chiusa nel suo mutismo.
«Odiavo il mio corpo. Oltre a ferirmi, vomitavo il cibo. Mi vergognavo, non riuscivo a parlarne coi miei genitori. Mia madre si arrabbiava molto quando vedeva i tagli. Solo in clinica sono riuscita ad aprirmi, a parlare della lametta». Alla clinica Santa Croce di Locarno, per la prima volta, la sofferenza della giovane trova un nome e una diagnosi: disturbo della personalità ‘borderline’. «In clinica mi tagliavo di più, forse perché anche gli altri lo facevano, inoltre quando sanguini gli infermieri ti curano, mi piaceva che si occupavano di me, mi piaceva essere al centro dell’attenzione», ricorda.
‘Ho deluso molte persone che amo, vedere i miei genitori piangere mi ha dato la forza di smettere, ci sto provando’
È da un mese che Nicole non si ferisce più. Ha un aspetto curato, le unghie sono pitturate, sul braccio ha tatuato un fiore sbocciato, ma il suo preferito è sul ventre. Mi mostra un enorme serpente. Anche lei spera di cambiar pelle, di lasciar andare un passato carico di momenti bui. Qualcosa dentro Nicole ha fatto clic. «Ho deluso molte persone che amo, vedere i miei genitori piangere mi ha dato la forza di smettere, ci sto provando. So che non devo ferirmi, so di aver davvero esagerato». In tasca ha un diploma di venditrice, sa parlare l’inglese che ha rispolverato con un soggiorno in Inghilterra, ma non ha un lavoro e per ora percepisce l’assistenza. Una situazione che vorrebbe cambiare. «Sto aspettando una risposta dalla Croce Rossa, mi sono candidata come volontaria per aiutare chi scappa dalla guerra in Ucraina», ci spiega.
Il suo volto si illumina, mentre ci parla dei suoi sogni. «Il mio hobby è fare tatuaggi, potrei farlo come lavoro, ma prima devo stare meglio». In clinica ci va due volte la settimana, segue dei corsi, c’è l’ergoterapista, le pastiglie sono gestite dalla madre. «Mi rendo conto di essere fortunata, oggi ho diversi punti di appoggio, la mia famiglia mi sta vicino e in clinica sono davvero bravi». Oggi ha il coraggio di parlare delle sue cicatrici. «Voglio aiutare chi non sa, perché l’autolesionismo è ancora un tabù».
Alla clinica psichiatrica Santa Croce a Locarno arrivano sempre più ragazzi in difficoltà. I nuovi ricoveri a settimana sono 3-4. Molti si infliggono lesioni e la psichiatra Sara Fumagalli è davvero preoccupata: «Questi ragazzi si sentono sbagliati, sono arrabbiati e si autopuniscono», dice la direttrice sanitaria della struttura.

Perché tanti adolescenti si tagliano gambe e braccia?
Questa urgenza di procurarsi dolore tagliuzzando la pelle (‘cutting’), strappandosi capelli, unghie, bruciandosi, vomitando, abusando di sostanze fino a star male… ha più spiegazioni, una è anche biologica. Segue lo stesso principio dell’agopuntura: stimolando le vie del dolore si attivano risposte endogene (il rilascio di ormoni come endorfine, ossitocina, dopamina) che leniscono il dolore stesso. Il dolore che cura il dolore. Ferirsi con una lametta è un modo per star meglio, per spegnere i pensieri, per sfuggire all’angoscia. Sembra un paradosso ma è quello che succede. Ovviamente esistono altri modi più sani per rilassarsi.
Si odia se stessi, il mondo e ci si ferisce per far uscire rabbia, dolore mentale, per punirsi?
Lo fanno per avere un sollievo. Da un lato c’è una ribellione verso una società che ha pressanti aspettative e non permette loro di essere se stessi. Questi ragazzi si sentono sbagliati, sono arrabbiati e si autopuniscono.
Vedete più casi?
C’è un considerevole aumento. Abbiamo 3-4 nuovi ricoveri a settimana di giovani con queste problematiche. Abbiamo avuto una crescita del 20% dei casi. Con l’azzeramento della vicinanza fisica, la pandemia ha fatto esplodere un malessere soggiacente. Nei loro disegni questi ragazzi chiedono più contatto fisico: non pastiglie, ma abbracci.
C’è anche esibizionismo o piuttosto una richiesta di aiuto?
Lavare la colpa punendo il corpo, è un retaggio antico del nostro collettivo. Come, quando e perché farlo è invece mutato. Ferirsi dà un sollievo temporaneo ma è anche un modo per attirare l’attenzione altrui. È un processo inconscio: mi ferisco e finalmente mio padre si occupa di me, mi ascolta, mi parla. Se funziona, lo rifaccio. Di regola, non c’è la volontà di farla finita. Chi si ferisce, non vuole più sentire il vuoto interiore, vuole smettere di soffrire. Dobbiamo ridare contenuti e significato alla vita stessa.
Tagliarsi può essere una crisi passeggera adolescenziale o è una spia da non sottovalutare?
Mai sottovalutare questi gesti. Sono segnali che esprimono un disagio. Ai genitori consiglio di non mostrarsi spaventati, di non reagire con apprensione, di non giudicare perché così facendo si rischia di fare ancora più danni. Occorre invece dare un significato alla richiesta di aiuto. Chi non viene ascoltato per anni o magari viene frainteso diventa un sopravvissuto e li vediamo arrivare in maggiore età in psichiatria, l’unico posto dove si sentono sicuri. E questo è decisamente aberrante.
Riguarda soprattutto le ragazze?
Il ragazzo tende a sfogare la rabbia all’esterno, le ragazze vivono intimamente la sofferenza. Entrambi sono immersi in un mondo adulto che ha rimosso il dolore, dove soffrire è un tabù, non puoi piangere, ma devi reagire e andare avanti. Si fatica a entrare in contatto con la sofferenza, riconoscerla, capire che fa parte della vita, darle un significato. Ai genitori consiglio di stare vicino ai propri figli quando soffrono, insegnare loro che sono delle fasi, dare loro gli strumenti per uscirne. A questi ragazzi manca la capacità di riflettere sui propri stati d’animo, non sopportano di deludere mamma e papà e quando succede si sentono sbagliati.
A quanti anni si inizia a farsi del male?
Gli esordi sono in età preadolescenziale, verso i 13 anni, quando un giovane entra nel mondo adulto ma è sprovvisto degli strumenti per affrontare scelte e frustrazioni. Il vuoto creato dall’angoscia lo riempie agendo, facendosi male.
Che cosa può fare un genitore?
Questi ragazzi cercano l’ascolto, emotivamente sono dei sopravvissuti. Alcuni genitori ci dicono che non riescono a entrare in contatto emotivo con il loro figlio: davanti alle braccia ferite stanno zitti o dicono ‘devi reagire’, alcuni non hanno proprio gli strumenti per aiutarli vuoi per mancanza di empatia, vuoi perché troppo giudicanti. Ai genitori consigliamo di seguire percorsi di gruppo di auto aiuto coordinati da una psicologa, li facciamo anche qui in clinica.
Come aiutate in clinica questi ragazzi?
Seguono un percorso con varie fasi. Prima li aiutiamo a imparare strategie alternative per lenire la sofferenza, per riempire il vuoto, come sfogare rabbia senza tagliarsi. Quando imparano a controllarsi, inizia la fase di riflessione. Li aiutiamo a dare un significato alle emozioni (anche alla rabbia) senza entrare nel giudizio; lavoriamo anche sulla consapevolezza del loro corpo con tecniche di mindfulness. Infine c’è la psicoterapia di gruppo e si lavora sulle relazioni, sui vissuti, su come costruire un’identità solida e integrata che li aiuta a entrare nel mondo degli adulti con una direzione più definita. Sarebbe opportuno fare prevenzione nelle scuole medie.