laR+
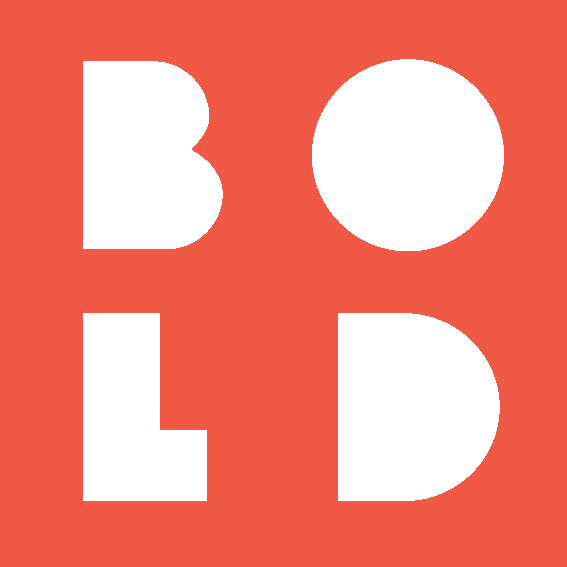
Franco Ambrosetti, il suono degli ottanta
Classe 1941, jazzista e imprenditore, ha suonato e ancora suona con i più grandi. Compie ottant’anni il 10 dicembre
‘La perfezione non esiste, la qualità sì. Ma quella è un’altra cosa’ (Foto: Pablo Gianinazzi - Ti-Press)