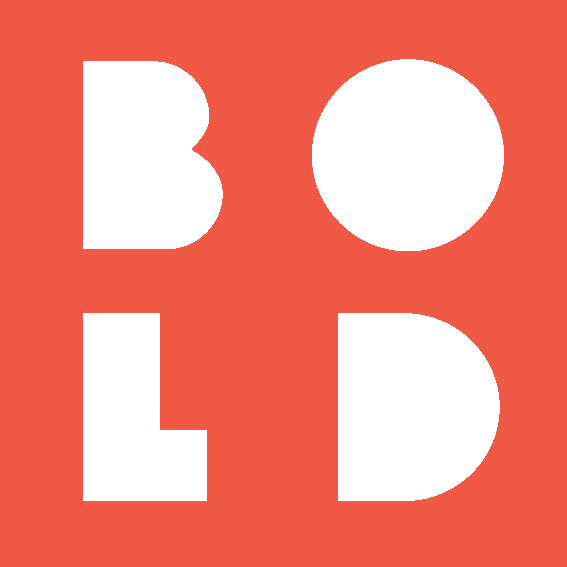
Talebani a Kabul, sopra gli eroi e le tombe
L’avanzata dei 'fanatici di Dio' è molto più rapida del previsto. La resa è nell’aria, il clima è quello da fine regno, la gente vuole fuggire ma non può
Le colline di Shaharak Omid Sabz sono diventate un enorme cimitero improvvisato (Roberto Antonini)