laR+ L’intervista
Dietro le sbarre di ‘Ariaferma’
Silvio Orlando e Tony Servillo, carcerato e carceriere nel film di Leonardo Di Costanzo, a Venezia prima e a Castellinaria 2021 poi, ora in sala
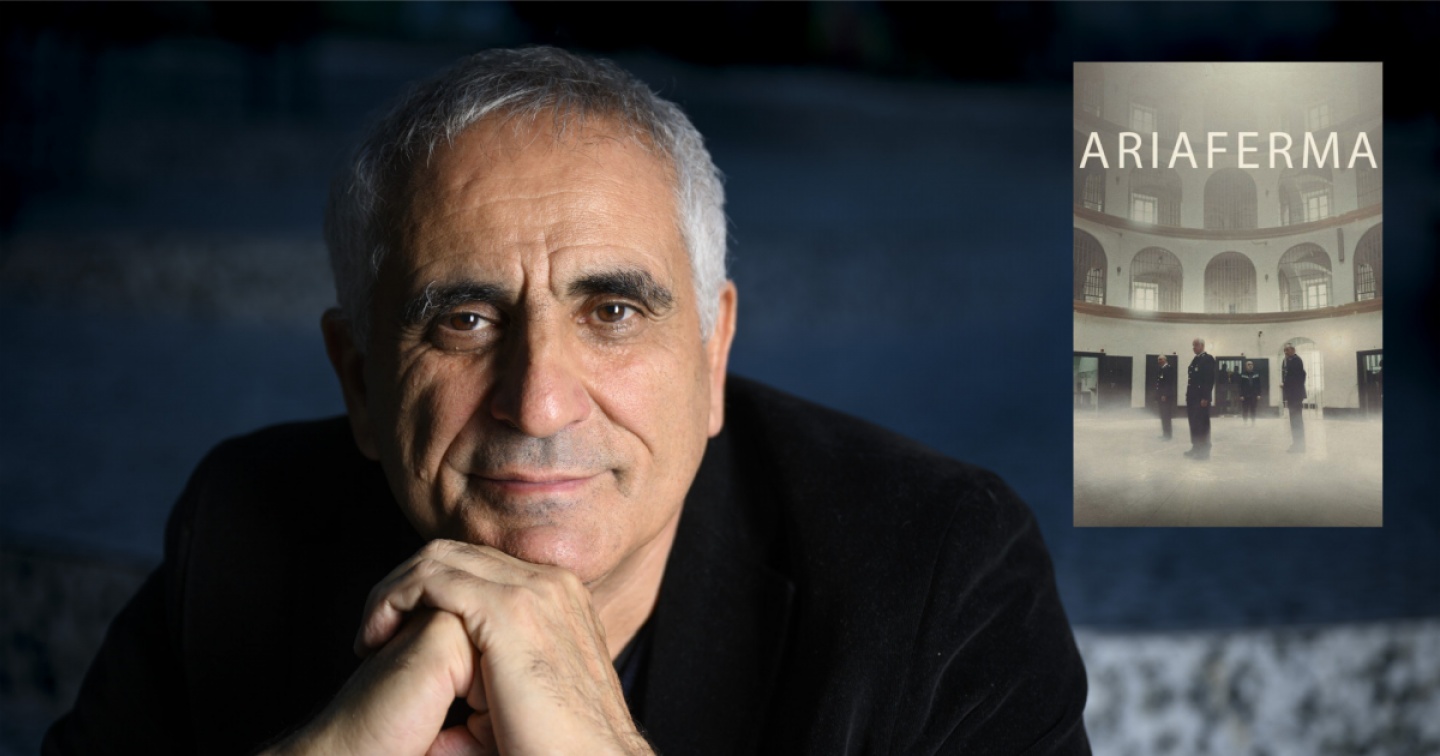
Leonardo Di Costanzo
(Keystone)
9 dicembre 2022
|
CULTURE


