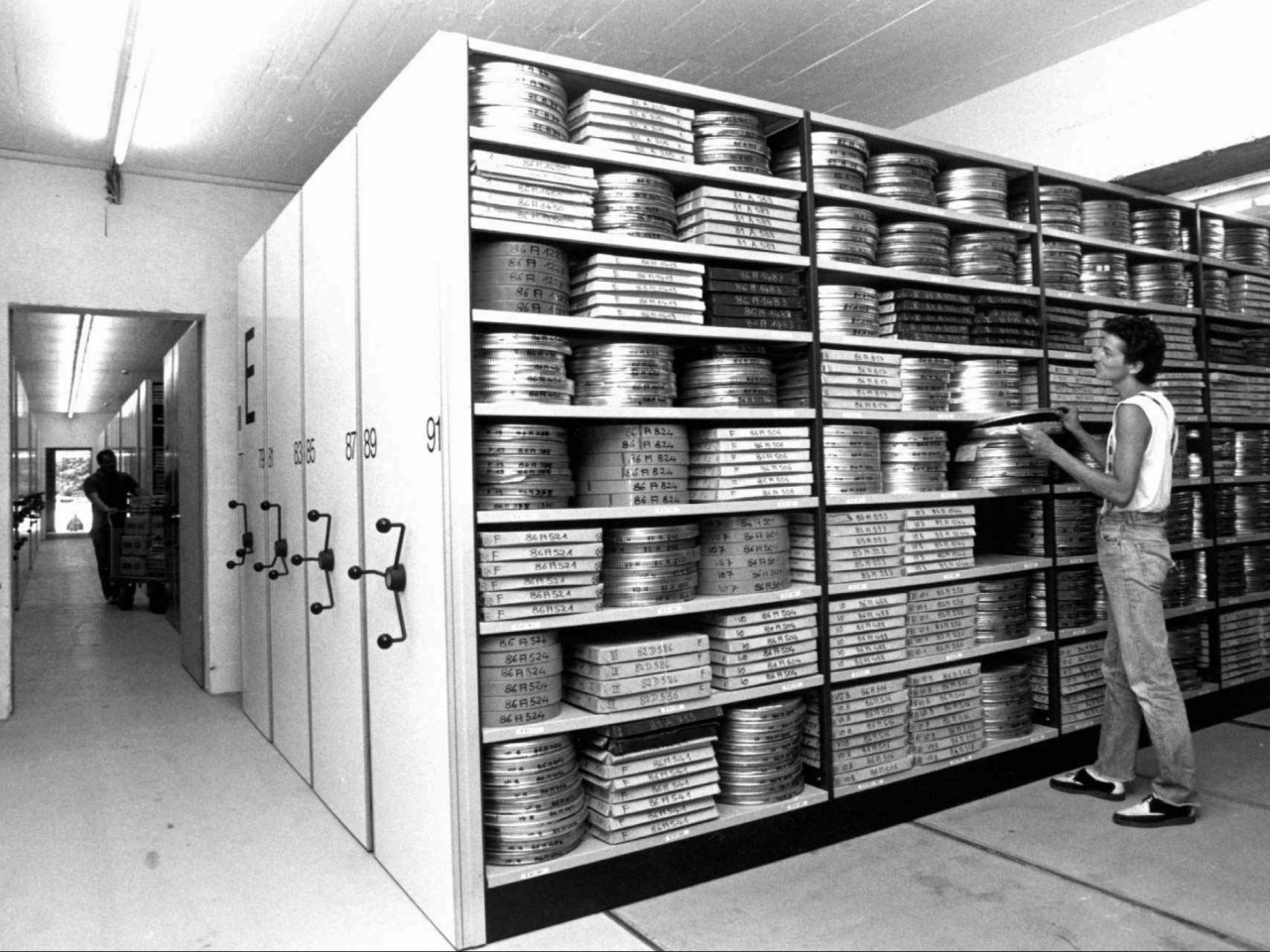Cinémathèque suisse, lo sguardo etnologico a Locarno
‘Les derniers passementiers’ e ‘Written Face’: presentati al Festival due nuovi restauri di due grandi autori svizzeri

La Cinémathèque suisse presenta al festival due nuovi restauri di due grandi autori svizzeri. Quando nel 1974 Les derniers passementiers / Die letzten Heimposamenter [Gli ultimi passamantieri] ha iniziato a circolare, poche persone potevano immaginare che in Svizzera esistessero ancora le strutture sociali ed economiche descritte da questo documentario. L’opera diretta da Yves Yersin, coadiuvato dal collega Eduard Winiger, fu commissionata al regista dalla Società Svizzera per le Tradizioni Popolari e ritrae gli ultimi lavoratori e le ultime lavoratrici della passamaneria attivi in ambito domestico.
Un settore fondamentale
Questo tipo d’industria era sorta in Svizzera a partire dal XVI secolo, in particolare nella zona di Basilea, e aveva vissuto il suo apogeo nel XVIII. L’industria della passamaneria (dal francese passement, ovvero pizzo o merletto), molto florida in passato, produceva bordure che servivano per decorare o rifinire abiti civili e militari od oggetti d’arredamento di vario genere. I fabbricanti basilesi di passamanerie producevano soprattutto nastri decorativi per l’industria tessile, per i cappellifici e per le confezioni dell’industria alimentare. Secondo quanto affermato da uno dei protagonisti a inizio del documentario, è stata proprio la presenza dell’industria della passamaneria, bisognosa di tinture e sostanze coloranti, a fare di Basilea una città ai vertici dell’industria chimica mondiale.
Le fabbriche si trovavano soprattutto a Basilea città, mentre buona parte del lavoro veniva svolto nelle case contadine di Basilea campagna. Yersin entra con la macchina da presa nelle case di lavoratori e lavoratrici, ormai anziani, di Basilea campagna e ci mostra con delicatezza la loro quotidianità fatta di gesti lenti, sapienti e meticolosi a ridosso delle macchine installate nella parte più luminosa della casa. Sono persone orgogliose del proprio mestiere, consapevoli di essere gli ultimi rappresentanti di una professione che si avviava ormai al suo definitivo declino. Quello che stupisce sono le caratteristiche del lavoro domestico: le donne e gli uomini davanti alla macchina da presa lavorano per lunghe ore sul loro macchinario, di proprietà esclusiva del datore di lavoro e, inoltre, si occupano spesso anche dei campi, degli animali o, quantomeno nel caso delle donne, dei lavori domestici e di cura dei figli. Ci troviamo confrontati con una dimensione industriale che conserva ancora degli elementi fortemente artigianali e premoderni. Le stesse case dei passamantieri sono prive degli elettrodomestici e delle comodità tipiche di una casa svizzera degli anni Settanta.
Yersin, che aveva già diretto oltre una dozzina di documentari sui mestieri in via di sparizione, riesce a mettere a proprio agio i protagonisti del documentario, lasciando loro la libertà di esprimersi in dialetto ed evitando di effettuare interviste classiche e frontali. L’autore romando non ha nascosto nemmeno gli aspetti più sgradevoli della condizione economica e sociale di questi lavoratori, pagati poco e sottoposti al ricatto della perdita del lavoro, ma nello stesso tempo ha dato voce anche agli stessi industriali, quasi tutti appartenenti a famiglie impegnate nel settore da generazioni.
Il gioco dell’identità
Il secondo film della Cinémathèque in programma nella sezione Histoire(s) du cinéma s’intitola ‘Written Face’ (1995). In questo documentario Daniel Schmid, grande nome della cinematografia elvetica di lingua tedesca, si reca in Giappone per conoscere da vicino la star del teatro kabuki Bandō Tamasaburō, interprete di ruoli femminili in costume tradizionale giapponese. Schmid non rinuncia all’intervista tradizionale, ma lascia enorme spazio alle performance del suo protagonista che spazia dal teatro kabuki ad altri generi più moderni della cultura scenica giapponese. Written Face è metà documentario e metà riflessione dell’autore sull’identità di genere, sul rapporto tra finzione e realtà. La recitazione di Bandō Tamasaburō è giocata attraverso il linguaggio del corpo, la gestualità stilizzata, l’utilizzo di costumi sgargianti e di un trucco pesante. Il tutto accompagnato dalla musica tradizionale giapponese suonata in scena da un ensemble di musicisti. Queste performance, con la prevalenza del visivo sul verbale, si sposano perfettamente con il medium cinematografico e ci riportano allo splendore di certo muto giapponese d’inizio Novecento.
Schmid gioca molto sull’identità scenica ed extrascenica di Tamasaburō che, secondo Haruko Sugimura, star del cinema giapponese intervistata da Schmid nel film insieme ad altre personalità artistiche del Sol levante, è capace di rendere i personaggi femminili meglio delle sue colleghe donne. Tamasaburō stesso non vuole rappresentare figure femminili, ma interpretare la sostanza di una donna. Lo ripete più volte durante il film. Si tratta di una concezione essenzialistica difficile da capire per noi occidentali, ma il risultato restituito dallo schermo è fortemente affascinante e squisitamente cinematografico.