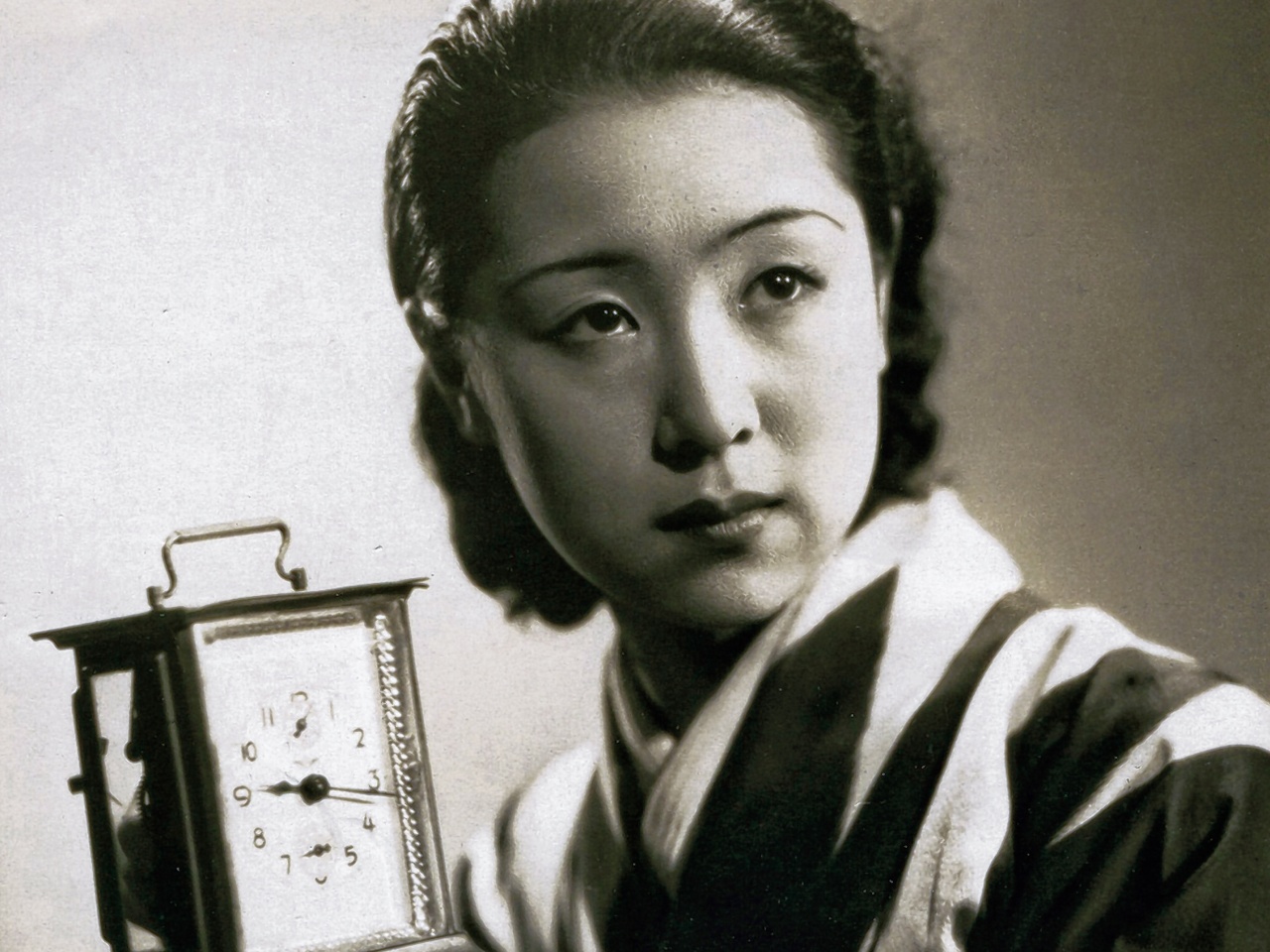La forza dell’immagine
Intervista al regista Paolo Taviani, cui il Festival ha reso omaggio mercoledì

Nel 1960 i fratelli Paolo e Vittorio Taviani, insieme al maestro del documentario Joris Ivens e su una sceneggiatura di Alberto Moravia, girarono un film che fece storia: ‘L’Italia non è un paese povero’. Ora che incontriamo Paolo Taviani, l’unico superstite di quel formidabile gruppo di cui faceva parte anche l’attore e regista Enrico Maria Salerno, alla luce delle “storie” italiane di oggi gli chiediamo che titolo darebbe a un documentario sull’Italia di oggi. Senza sorridere, con voce amara ma non mesta egli ci risponde: «L’Italia è un paese squallido», senza aggiungere altro. Troppo forte è il suo detto, ci fa tremare. L’incontro è a Locarno, sulle rive del lago. Guardiamo quest’uomo pimpante e sicuro, presto ottantasettenne, appena toccato dall’immenso dolore della perdita del fratello e complice Vittorio; apprezziamo la sua disponibilità, gli sussurriamo le nostre condoglianze, e ci abbracciamo, come si fa tra uomini.
Proviamo a spiegargli che molti dei film prodotti da giovani e giovanissimi visti qui a Locarno privilegino la parola rispetto all’immagine, risultato lontano da quello che usciva dai Cineclub in cui anche i Taviani erano nati, oggi l’abitudine al telefonino, al parlato, influenza anche il dire nei film. Lui ci guarda prima di rispondere: «Non ci avevo pensato a questo aspetto, è vero. Noi non potevamo sprecare le immagini, un giovane ora ha grandi possibilità grazie al digitale: con i telefonini fanno dei film migliori di quelli che facevamo noi – a guardarli in superficie, ma poi se li guardi meglio, molto spesso sono gran stronzate. Sono però sicuro che la forza dell’immagine tornerà a vincere, perché la parola verrà a noia, si tornerà a quello spettacolo strano che è il cinema».
Come trova oggi il cinema italiano di cui voi siete stati grandi protagonisti? «Trovo il cinema italiano oggi in un momento di gran vivacità. Certo bisogna distinguere tra chi fa film per far cassetta e chi invece non parte con il desiderio di incassare. Riusciamo a distinguerli perché i primi sono rappresentazioni comiche, gli altri sono più di ricerca, seguono quello in cui noi credevamo negli anni 60: non diamo al pubblico quello che il pubblico ci chiede, ma diamo quello che non sa chiedere».
In concorso qui a Locarno c’è un film girato in 16 mm, quanto pensa sia importante nel dire attraverso il cinema il tipo di ripresa che si usa? «Penso che ogni regista debba pensare a come dire il suo film. Io e Vittorio per ‘Padre padrone’ non avevamo abbastanza soldi per girarlo in 35 mm. E allora lo abbiamo girato in 16 pur di farlo. Era nato per la televisione e stava per essere trasmesso, quando intervenne un selezionatore di Cannes che ci chiese di portarlo sulla Croisette, era il 1977. Noi eravamo stati delusi nel 1975 quando eravamo convinti di essere al Festival con ‘Allonsanfàn’ ma al posto nostro presero ‘Yuppi Du’ di Celentano e noi andammo alla Quinzaine des Réalisateurs. Fu per questo che ci presero in Concorso, il problema era che il film per essere presentato doveva essere trasferito in 35, nel passaggio si perse il sopra e il sotto dell’immagine e il tutto risultava un po’ sfocato. Io e Vittorio eravamo distrutti e dopo la proiezione anche amareggiati, perché il pubblico era uscito senza parlare. Non so descrivere quello che successe poi: ci aspettavano fuori per decretare il nostro trionfo. Il nostro amico Joris Ivens si congratulò con noi per quell’effetto flou, per quelle immagini sfocate». Com’è nata l’idea di ‘Cesare deve morire’? «È nata dalla frase di uno dei protagonisti, un carcerato, accusato di tre omicidi, che ci disse: “Da quando ho conosciuto l’arte, questa mia cella è diventa prigione”. Queste parole ci colpirono e diedero un senso alla nostra voglia di fare un film con i carcerati sul Giulio Cesare di Shakespeare».
Molte ancora le cose da dire, ma il tempo dell’intervista è finito. Grazie vecchio Signore, Grande Regista