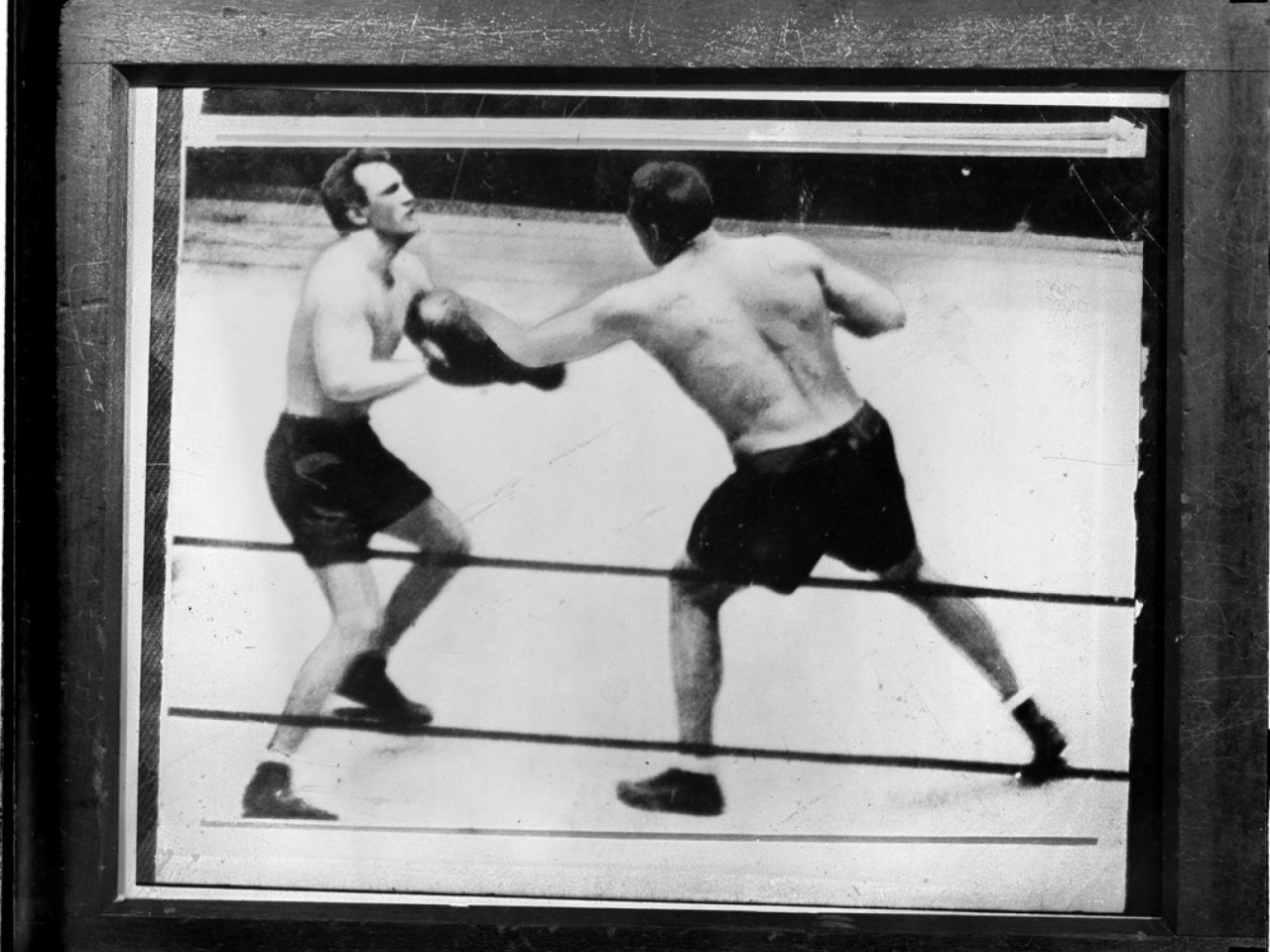Lo sbarco in Sicilia e il ‘grande complotto’
Ottant’anni dopo, un agile saggio smentisce la teoria che vede la mafia dietro al successo angloamericano, un mito che ha fatto comodo a molti

Giornalisti, scrittori, perfino due commissioni parlamentari: sono stati – e sono – in tanti a credere che lo sbarco degli angloamericani in Sicilia, il 10 luglio di ottant’anni fa, sia stato ‘opera’ della mafia. Ovvero che la cosiddetta Operazione Husky fosse il risultato d’un complotto tramato dai servizi segreti Usa e dalla malavita organizzata americana e siciliana, la quale avrebbe reso possibile la rapida avanzata dei soldati sull’isola in cambio di una “cogestione” del territorio. A dimostrarlo, secondo i propalatori di questa narrazione, alcuni eventi: la liberazione del gangster newyorchese Lucky Luciano subito dopo il conflitto, la nomina da parte del governo militare alleato di sindaci e funzionari in odore di mafia, il ritorno più generale della presenza mafiosa che pareva in ritirata durante gli anni del fascismo. L’ipotesi è suggestiva, e poi permette di farci tante cose: dare la colpa agli Yankee per il predominio mafioso sul dopoguerra meridionale, oppure rappresentare il Ventennio come epoca in cui da quelle parti vigevano legge e ordine, signora mia. La stessa mafia italoamericana ne approfittò per rivendersi poi, a scopo di marketing diplomatico, come ‘patriota’ nella lotta contro Mussolini e Hitler. Il problema è che cotanto pactum sceleris è una bufala, anzi: un mito. Quel ‘Mito del grande complotto’ (Donzelli, 2023) che dà il titolo a uno snello e affascinante saggio di Salvatore Lupo, già professore di Storia contemporanea all’Università di Palermo e tra i massimi storici della mafia.
Professor Lupo, è un fatto che Lucky Luciano fu contattato dai servizi d’intelligence della Marina americana nel corso del conflitto: la cosiddetta Operation Underworld. Perché mai avrebbero dovuto farlo, se non per ottenere sostegno e informazioni in previsione dello sbarco in Sicilia?
Innanzitutto, perché l’operazione Underworld risale all’inizio del 1942, quando lo sbarco in Sicilia non era minimamente contemplato. In quel momento gli Stati Uniti, precipitati nel conflitto, avevano come priorità quella di difendere le proprie linee di comunicazione con l’Europa dalla guerra sottomarina. Inoltre, essendo un Paese multietnico con molti immigrati legati alle nazioni europee schierate le une contro le altre, temevano di non reggere l’urto di una prova ‘morale’ come quella guerra. In questo contesto, le relazioni con Luciano e altri gangster italoamericani miravano a garantire la sicurezza sul porto di New York, in cui l’ordine era tradizionalmente gestito da quegli stessi gangster attraverso i sindacati. Ecco perché la Marina si rivolse a loro, come dimostrano le successive indagini e una vasta documentazione. Avvicinandosi poi la decisione di sbarcare in Sicilia – quindi solo all’inizio del ’43, dopo aver scartato altri approdi – è possibile che da quei mafiosi si sia cercato anche di ottenere informazioni sull’isola. Però dalle fonti non risulta il coinvolgimento dei boss più importanti, anche perché le comunicazioni con l’Europa erano compromesse dal conflitto e la stessa Operazione Husky era coperta dal massimo riserbo, per cui possiamo anche escludere che qualche criminale in Sicilia ne fosse al corrente e potesse fare da ponte.
Fin dall’inizio i sostenitori di questo mito – a partire dal giornalista Michele Pantaleone nel fortunatissimo ‘Mafia e politica’ del 1962, fino alle commissioni antimafia nei loro rapporti del 1976 e del 1993, annus horribilis di stragi mafiose in tutta Italia – notarono alcune coincidenze sospette: anzitutto l’avanzata rapida e agevole delle truppe in un territorio tutt’altro che agevole. Dove sbagliano?
Sbagliano perché non fu così: la battaglia di Sicilia fu invece molto aspra, e implicò per tedeschi e parte degli italiani di potersi ritirare sul continente nonostante l’arrivo di un avversario schiacciante. Non a caso lo storico militare americano Carlo D’Este intitolò un suo volume sul tema ‘Bitter Victory’, vittoria amara, che non assicurò tutti i vantaggi strategici sperati. Certo, a sudovest l’avanzata fu rapida perché l’Asse si concentrò invece sulla linea difensiva che consentiva la ritirata verso Messina. Ma l’operazione fu comunque durissima. A crollare rapidamente fu semmai il fronte interno italiano: dopo 15 giorni cadde il regime fascista, una disintegrazione dovuta però non alla mafia, bensì a un livello ormai insostenibile di incapacità e delegittimazione. A guerra persa, il mito del complotto tornerà invece utile a neofascisti e monarchici per la costruzione di una dietrologia autoassolutoria.
Un altro elemento che tale dietrologia brandisce è il ritorno in grande stile, dopo lo sbarco, della presenza mafiosa sul territorio siciliano. Secondo questa lettura, Cosa Nostra era stata invece ridotta al lumicino dai fascisti, grazie a operazioni repressive come quella del prefetto Cesare Mori nel 1926.
Ma la mafia non fu affatto distrutta dal fascismo: alla fine degli anni 30 era ancora ben viva. Un rapporto di polizia del 1938 riconosceva già che dopo l’operazione Mori “le basi e le radici rimasero intatte”, e sappiamo che i cosiddetti “stati maggiori” rimasero attivi. Non fu dunque lo sbarco a ricostituire la mafia. E la mafia, a sua volta, non fu affatto determinante né per la scelta di sbarcare proprio in Sicilia, né per la vittoria degli Alleati.
Possiamo almeno affermare che il governo militare angloamericano finì davvero per scendervi a patti al momento di gestire l’isola? Dopotutto, personaggi famigerati come il sindaco da loro appuntato a Villalba, Calogero Vizzini detto ‘Don Calò’, erano effettivamente capimafia.
Certo, peraltro Calò non fu l’unico mafioso a essere favorito negli equilibri del potere locale. Ma era molto appoggiato anche dalla Curia di Caltanissetta. In questo come in altri casi, si può dire che il tentativo angloamericano di costruire un’amministrazione civile – svoltosi nella confusione della guerra – li portò ad affidarsi anche a mafiosi ‘mascherati’ da antifascisti. Va detto d’altronde che coloro che venivano smascherati erano spesso destituiti. Non capisco dunque perché insistere su quel frangente, quando le amministrazioni italiane successive si sarebbero dimostrate a loro volta assai tolleranti e permeabili davanti al fenomeno mafioso.
Forse perché faceva comodo: alla sinistra per incolpare gli Yankee e di rimbalzo i loro protégé democristiani; ai partiti di governo come la stessa Dc per non riconoscere i propri errori e connivenze; ai neofascisti per lucidare il busto d’un Ventennio in cui la Sicilia era più sicura.
Si tratta in effetti di una soluzione di comodo. Utile anche per giustificare la sopravvivenza della mafia, ritenuta un fenomeno socialmente e culturalmente arretrato, che sarebbe dovuto scomparire spontaneamente all’avanzare della modernizzazione. In realtà, se ciò non è accaduto non è dovuto a chissà quale trama, ma al fatto che la mafia non era poi un fenomeno così arcaico. In questo senso, il vero ruolo dei gangster italoamericani fu proprio quello di contribuire alla modernizzazione di Cosa Nostra e dei suoi affari nel corso del Novecento: questo, semmai, è il vero ‘complotto’ siculoamericano.
Come si mosse politicamente la mafia durante l’occupazione angloamericana, che peraltro vide la messa fuorilegge temporanea di partiti di massa come quelli di socialisti, comunisti e democristiani?
Nel 1943 la Sicilia si ritrovò in una sorta di dopoguerra anticipato rispetto al resto d’Italia, con un’incertezza sugli esiti del conflitto che a sua volta ne alimentò l’illusione di diventare indipendente. Per tutelare i propri interessi, la mafia saltò subito sul cavallo d’un separatismo che piaceva anche a molti notabili e latifondisti locali: il Movimento per l’indipendenza siciliana è sicuramente quello più inquinato di sempre dalla presenza mafiosa. Gli americani però non lo avallarono e sostennero invece la sistemazione unitaria, tanto che i mafiosi si trasferirono armi e bagagli sul carro della Democrazia Cristiana.
Un altro elemento ‘sospetto’ è la liberazione – con espulsione in Italia – di Lucky Luciano nel 1946: sicuri che non ci sia un legame con qualche aiutino allo sbarco?
La liberazione fu piuttosto l’esito di dinamiche interne agli Stati Uniti, che in Italia non vennero comprese. Luciano – reclutato come detto per garantire la sicurezza a New York – fu liberato verosimilmente a riconoscimento di quell’aiuto, magari anche ingigantito a opera della mafia siculoamericana e dunque sopravvalutato dall’allora governatore dello Stato, il repubblicano Thomas Dewey. Il tutto in un contesto che vedeva i Democratici newyorchesi di Tammany Hall – che tradizionalmente basavano molto del loro potere sui gangster della città – più che interessati a rovesciare il tavolo rappresentando l’avversario Dewey come un venduto agli occhi dell’elettorato. La mancata conoscenza di questo ‘fronte interno’ contribuisce invece in Italia a leggere quell’episodio come parte del grande complotto.
Non sarà questa l’ultima teoria cospirazionista nella storia della Repubblica italiana: si pensi ad esempio al mito del ‘grande vecchio’ che si nasconderebbe dietro agli Anni di piombo, o alle più fantasiose letture della presunta trattativa Stato-mafia per porre fine alle stragi del 1992-93. Trova analogie tra queste vicende?
Delle analogie ci sono, e in tutti i casi – per inclinazione personale, ma anche per mestiere – diffido delle teorie del complotto che paiono spiegare e ridurre alla malvagità di pochi attori fenomeni collettivi. Vale per il terrorismo, ma anche per la mafia, che non si può considerare un’entità monolitica e onnisciente, in grado di prevedere e controllare tutto. Io credo che eventi, intrighi, meccanismi d’azione e reazione dipendano da fattori molto più ampi ed eterogenei, anche per quanto riguarda la condotta delle autorità istituzionali: come a New York nel 1942, è possibile che nell’Italia delle stragi alcuni loro rappresentanti si siano lasciati tentare dall’idea di ‘risolvere le cose’ affidandosi a questo o quel mafioso; ma non sono grandi complotti. Questo vale forse anche per la cosiddetta trattativa Stato-mafia, per la quale d’altronde va ricordato che alla fine sono stati tutti assolti.
È possibile che il grande costrutto dietro alle inchieste su quella trattativa sia dovuto a inquirenti che si vogliono sostituire agli storici? Che ci sia cioè una confusione tra l’approccio giuridico – che dovrebbe perseguire illeciti puntuali identificando responsabilità anzitutto individuali – e l’approccio storico, che invece aspira a ricostruire una temperie più generale, al di là di quanto circoscritto dai codici?
Lo penso anch’io, anche se occorre tenere conto del fatto che i processi per mafia devono confrontarsi con grandi quantità di soggetti coinvolti e con tempi molto lunghi, basti pensare all’avvicendarsi delle generazioni e all’intrecciarsi dei legami famigliari, così centrali per Cosa Nostra. Il fatto che un certo concetto di responsabilità individuale si perda nella considerazione di fatti sociali più articolati – da riservare piuttosto alla storiografia – è dunque dovuto anzitutto alla complessità del problema, non alla cattiva volontà di questo o quel giudice.