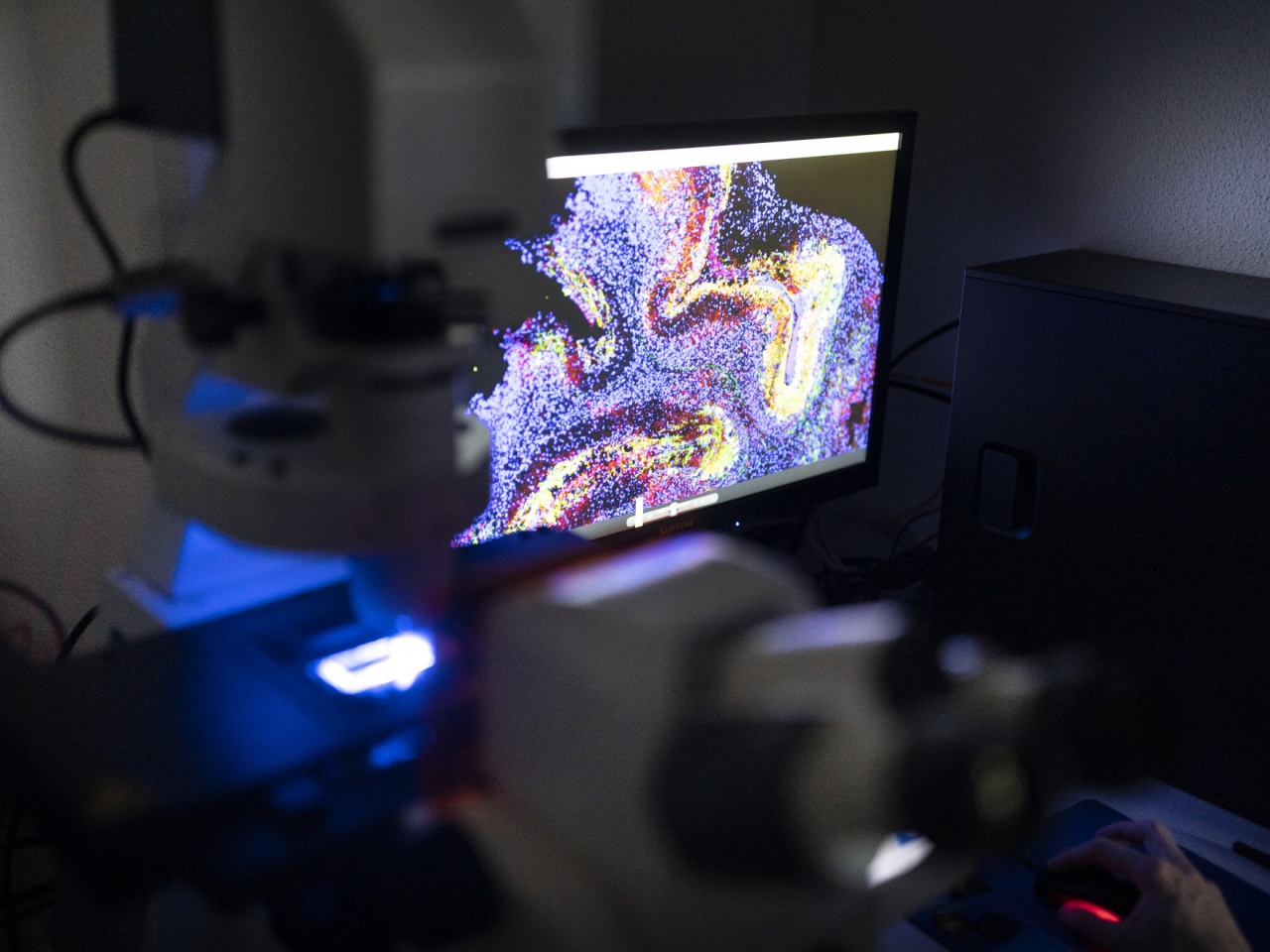L’assassino è ‘Uno di noi’ (Utøya, 22 luglio 2011)
Il 26 gennaio, l’audiodramma sale sul palco del Sociale. A colloquio con Sergio Ferrentino, che cura regia e adattamento, fondatore della Fonderia Mercury

Oslo, 22 luglio 2011. Alle 15.25, un’autobomba esplode nei pressi degli edifici del governo norvegese, facendo 8 morti e diversi feriti; mentre le forze dell’ordine convergono nel centro cittadino, un uomo vestito da poliziotto sale a bordo di un traghetto diretto all’isola di Utøya, dove è in corso il campus organizzato dal Partito laburista norvegese; giunto a destinazione, il finto agente dice di trovarsi lì per cercare una bomba, poi imbraccia un fucile semiautomatico e in un’ora e mezza di caccia all’uomo uccide 69 persone tra i 14 e i 51 anni.
«Poco dopo la prima esplosione, quasi tutti gli organi d’informazione hanno pensato al terrorismo islamico, per poi scoprire che Anders Breivik era un norvegese, bianco, vicino all’estrema destra. Era uno di loro. Lo spettacolo non poteva che avere questo titolo». Dall’attacco più sanguinoso che la Norvegia ricordi dai tempi della Seconda guerra mondiale, nel 2021 Sergio Ferrentino ha realizzato e diretto ‘Utøya. Uno di noi’, radiodramma in dieci puntate prodotto dalla Rsi per Rete Due. Il prossimo 26 gennaio, nei pressi della Giornata della Memoria, l’opera va in scena al Teatro Sociale. Sul palco («Forse non è il momento per un cast così numeroso, ma così è»), undici attori anche ticinesi: Claudio Moneta, Gabriele Calindri, Daniele Ornatelli, Renata Bertolas, Alessandro Castellucci, Riccardo Buffonini, Dario Sansalone, Margherita Saltamacchia, Eleni Molos, Michela Atzeni e Marta Lucini.
L’intervista
‘I podcast? È tutto confuso e infelice’
«La Norvegia è un caso importante, perché era attrezzata a individuare le potenziali minacce che fossero arrivate dall’esterno, e se Breivik fosse stato una di queste minacce, sarebbe stato preso subito. Ma la nazione non era attrezzata per l’eventualità interna, l’elemento più drammatico di questa vicenda». Nato a Ivrea, terra d’innovazione tecnologica, già direttore dei programmi di Radio Popolare – a fine anni Ottanta, dal suo ‘Bar Sport’ uscì la Gialappa’s – Ferrentino è sinonimo di ‘Caterpillar’, storico programma radiofonico Rai da quasi settecento puntate, prima di differenziarsi in ‘Catersport’. È anche sinonimo di drammaturgia radiofonica in casa Rsi. E libri, televisione, tanto teatro come autore, regista e produttore, e tanto insegnamento. S’identifica con lui anche la Fonderia Mercury, luogo di creatività sotto la cui egida – dal pressoché omonimo libro di Åsne Seierstad – giunge a Bellinzona ‘Utøya. Uno di noi’ (da ascoltarsi con le radiocuffie distribuite all’ingresso in sala).
Sergio Ferrentino, l’azione di Anders Breivik che lei porta in scena rappresenta, dal punto di vista mediatico, uno scarto, una progressione...
Certamente, c’è un salto qualitativo nel gesto di Breivik, che per molto tempo non è stato messo a fuoco. Purtroppo abbiamo fatto una certa abitudine alle stragi, al singolo che va e spara. Nelle scuole statunitensi, per esempio. In Norvegia, invece, il meccanismo è stato più complesso: Breivik ha voluto colpire sì dei giovani, ma giovani impegnati, che facevano politica. Nel processo dichiara la sua intenzione di azzerare il futuro della classe dirigente norvegese. Usa la parola "giustiziati", e non "assassinati".
Ciò che è stato sottovalutato, dal punto di vista mediatico, è la nuova strategia stragista, il fatto che ogni singola persona possa diventare un esercito in battaglia. Il passo è breve da Utøya alla Nuova Zelanda, l’attacco alle due moschee che causò 22 vittime e i riferimenti a Breivik trovati a casa dell’attentatore. Altri fatti di sangue di questo tipo sono accaduti a Milano, dove l’assalitore si faceva chiamare Breivik, e due anni prima a Savona. Persone singole, o piccoli gruppi. Ma per quanto piccolo possa essere, il gruppo rimane facile da identificare. L’elemento cardine di Breivik e del pericolo odierno, invece, sta in due parole: "incensurato" e "solo".
‘Utøya. Uno di noi’ è il radiodramma trasferito sul palcoscenico. Gesto rivoluzionario, quasi voyeuristico il suo, da molto tempo. Ha portato in scena finanche tecnici e rumoristi: quando la prima volta?
Nel 2001. Insegnavo alla Scuola Holden di Torino, ma realizzavo audiodrammi già dai tempi di Radio Popolare. Quell’anno feci scrivere ai miei allievi l’adattamento radiofonico di alcuni racconti, quello che oggi si chiama ‘adattamento audio’. L’idea di fondo è che l’audiodramma è uno spettacolo, perché vedi cose che nemmeno immagini. È anche qualcosa "per non vedenti", come si diceva un tempo, e va costruito in funzione della chiarezza della storia, lavorando alla cosiddetta ‘costruzione dell’immagine acustica’. In questo gioco, è come entrare di nascosto nello studio de ‘La Guerra dei mondi’ di Orson Welles e scoprire che i sessanta personaggi di quella storia sono in realtà cinque attori soltanto, che i rumori sono tutti costruiti in quel luogo e che tutto è falsato. "La radio mente", come si diceva nel ’68.
La sua Fonderia Mercury è, cito testualmente, "luogo nel quale fondere i linguaggi e sperimentare contaminando". Prende il nome da Mercury Theatre, la compagnia teatrale di Orson Welles che negli studi della Cbs recitò proprio ‘La Guerra dei mondi’. Mi pare che quell’invasione aliena abbia segnato la sua vita…
È così. E mostrare la costruzione di un radiodramma è una delle cose più divertenti. Con la Fonderia Mercury ho subito coinvolto autori, perché in Italia non ci sono autori di radiodrammi. Lucarelli, Carlotto, Dazieri, Bajani, Bucciarelli, Corrias hanno osato affrontare una drammaturgia radiofonica che da noi è assolutamente marginale e invece nel Kent ha un suo corso di laurea. Certo, la tradizione della Bbc conta, ma accade anche in Germania. Scrivere per l’audio è qualcosa che bisogna imparare e insegnare. Nel 2002 abbiamo stretto un rapporto con la radio svizzera che prosegue tuttora, e continuiamo a produrre e a sperimentare perché cambiano i mezzi di produzione – i microfoni, la tecnica – e le tecniche di recitazione, legate a quella costruzione dell’immagine acustica di cui si diceva. All’inizio si chiamavano ‘Radiodrammi in teatro’, ora si chiamano ‘Audio in teatro’, perché l’audio in realtà va anche sui podcast.
Nel 1938, lo sbarco di extraterrestri in una fattoria del New Jersey fu la bufala del secolo: bombardati di bufale come siamo, sarebbe qualcosa di ricreabile oggi?
È chiaro che non è più possibile ottenere quella dinamica. Quel tipo di riuscita si deve al fatto che era il 1938 e non c’era la televisione, che tutti avevano al massimo una radio e non la potevano ascoltare in auto, e che quel milione e 600mila persone circa, calcolate dagli studiosi, fuggirono immediatamente senza sentire gli appelli che segnalavano che si trattava di un radiodramma. Oggi sarebbe difficile, perché i mezzi di comunicazione sono molti e onnipresenti. Una quindicina di anni fa, sempre con la Scuola Holden, facemmo per la radio svizzera ‘In fondo la notte’, una ‘Guerra dei mondi’ aggiornata al 2005. L’elemento cardine fu che non avremmo potuto pensare a un’invasione fisica e che avremmo dovuto affrontare la ‘supercomunicazione’ (per chi nel 2005 non era all’ascolto, si rimanda ad Audible, ndr). Quello che scoprimmo, con quell’indagine, fu che il mondo è impreparato per le prime 24 ore, qualsiasi sia l’attacco. Come per il primo tsunami: dopo il terremoto in Indonesia, nessuno credeva che l’onda sarebbe arrivata sulle spiagge, e non fu diramato alcun allarme.
Ha parlato di podcast. Ormai ci stampiamo le foto in casa, registriamo i dischi in casa, ora possiamo finalmente fare la radio in casa. In fondo, chi se ne frega dei fotografi, chi se ne frega dei fonici…
Citerò i poeti, il tutto è "confuso e infelice". Intanto si è soliti dire "ho fatto un podcast" come se fosse un genere, e invece il podcast è un mezzo. E non basta registrare la propria voce per fare un podcast, è il grande equivoco: a lei ricorda la musica, a me ricorda le radio libere in Italia, quando andavano in onda proprio tutti. Io vengo da quindici anni di Radio Popolare, e anche quella era una radio libera, ma un conto erano le radio commerciali a fini di lucro, e un conto le radio che facevano informazione, una cosa era fare programmi di dischi a richiesta e un’altra fare notiziari, creare programmi, inventare.
Viviamo oggi quella stessa fase di confusione nella quale un po’ tutti possono fare podcast, o ‘pensano’ di fare podcast. In tutto questo, la cosa più drammatica è che dei podcast mancano le recensioni. La cosa vale anche per le radio: si annuncia la nascita di una trasmissione, ma non c’è più nessuno che ne faccia la recensione. D’altra parte, quale giornale si farebbe la recensione negativa del podcast che produce? Podcast che di norma viene messo nella homepage e siccome ci entrano in tanti, si pensa che quello sia un podcast di successo.
Un circolo vizioso. Innegabile, però la forza del podcast…
Certo, il podcast è una grandissima occasione, e si svilupperà anche da noi come è accaduto negli Stati Uniti, in Canada, Australia, e con certo ritardo anche in Germania. L’occasione è che prima del suo avvento, il mondo dell’audio era all’interno della radio, e ora lo spazio a disposizione è enorme. Certo, rispetto alla radio si perde molto: non potrei replicare Caterpillar all’interno di un podcast, mancando tutta l’imprevedibilità, l’immediatezza della diretta. Ma in radio è cambiato il tipo di ascolto, e sottolineo ascolto: è sempre più "radio tappezzeria", un vecchio appellativo per la radio messa di sottofondo, cosa che per altro ha una sua funzione. La radio ha questo grande problema, da ormai trent’anni è passata da mezzo di comunicazione di massa a mezzo che gestisce la massa della comunicazione. Al di là di questo, una cosa è sentire e un’altra ascoltare. La semplifico così: quando sei in auto e ascolti, di solito sbagli l’uscita dell’autostrada.